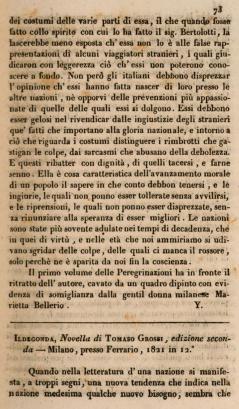
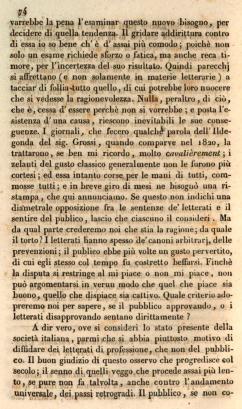
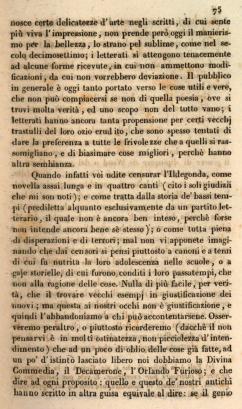
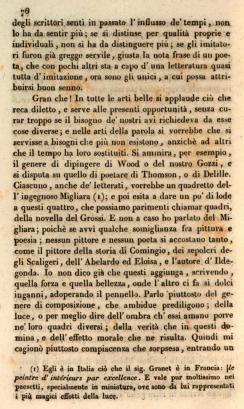
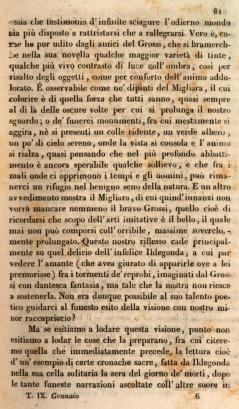
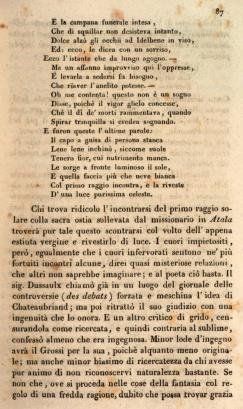
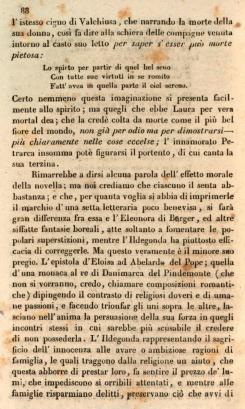
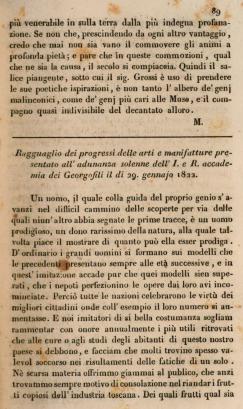
ILDEGONDA, Novella di TOMASO GROSSI, edizione seconda – Milano, presso Ferrario, 1821 in 12.°
Quando nella letteratura d'una nazione si manifesta, a troppi segni, una nuova tendenza che indica nella nazione medesima qualche nuovo bisogno; sembra che varrebbe la pena l'esaminar questo nuovo bisogno, per decidere di quella tendenza. Il gridare addirittura contro di essa io so bene ch è d' assai più comodo; poichè non solo un esame richiede sforzo o fatica, ma anche reca timore, per l'incertezza del suo risultato. Quindi parecchj si affrettano (e non solamente in materie letterarie) a tacciar di follia tutto quello, di cui potrebbe loro nuocere che si vedesse la ragionevolezza. Nulla, peraltro, di ciò che è, cessa d'essere perchè non si vorrebbe; e posta l'esistenza d'una causa, riescono inevitabili le sue conseguenze. I giornali, che fecero qualche parola dell'Ildegonda del sig. Grossi, quando comparve nel 1820, la trattarono, se ben mi ricordo, molto cavalièrement; i zelanti del gusto classico generalmente non le furono più cortesi; ed essa intanto corse per le mani di tutti, commosse tutti; e in breve giro di mesi ne bisognò una ristampa, che qui annunciamo. Se questo non indichi una diametrale opposizione fra le sentenze de' letterati e il sentire del publico, lascio che ciascuno il consideri. Ma da qual parte crederemo noi che stia la ragione; da quale il torto? I letterati hanno spesso de' canoni arbitrarj, delle prevenzioni; il publico ebbe più volte un gusto pervertito, di cui egli stesso col tempo fu costretto beffarsi. Finchè la disputa si restringe al mi piace o non mi piace, non può argomentarsi in verun modo che quel che piace sia buono, quello che dispiace sia cattivo. Quale criterio adopreremo noi per sapere, se il pubblico approvando, o i letterati disapprovando sentano dirittamente?
A dir vero, ove si consideri lo stato presente della società italiana, parmi che si abbia piuttosto motivo di diffidare dei letterati di professione, che non del pubblico. Il buon giudizio di questo osservo che progredisce col secolo; il senno di quelli veggo che procede assai più lento, se pure non fa talvolta, anche contro l'andamento universale, dei passi retrogradi. Il pubblico, se non conosce certe delicatezze d'arte negli scritti, di cui sente più viva l'impressione, non prende però oggi il manierismo per la bellezza, lo strano pel sublime, come nel secolo decimosettimo; i letterati si attengono tenacemente ad alcune forme ricevute, in cui non ammettono modificazioni, da cui non vorrebbero deviazione. Il pubblico in generale è oggi tanto portato verso le cose utili e vere, che non può compiacersi se non di quella poesia, ove si trovi molta verità, ed uno scopo non del tutto vano; i letterati hanno ancora tanta propensione per certi vecchj trastulli del loro ozio erudito, che sono spesso tentati di dare la preferenza a tutte le frivolezze che a quelli si rassomigliano, e di biasimare cose migliori, perchè hanno altra sembianza.
Quando infatti voi udite censurar l'Ildegonda, come novella assai lunga e in quattro canti (cito i soli giudizio che mi son noti); e come tratta dalla storia de' bassi tempi (prediletta alquanto esclusivamente da un partito letterario, il quale non è ancora ben inteso, perchè forse non intende ancora bene sè stesso); o come tutta piena di disperazioni e di terrori; mal non vi apponete imaginando che dai censori si pensi piuttosto a canoni e a temi di cui fu nutrita la loro adolescenza nelle scuole, o a gaje storielle, di cui furono conditi i loro passatempi, che non alla ragione delle cose. Nulla di più facile, per verità, che il trovare vecchi esempj in giustificazione dei nuovi; ma questa ai nostri occhi non è giustificazione, e quindi l'abbandoniamo a chi può accontentarsene. Osserveremo peraltro, o piuttosto ricorderemo (dacchè il non pensarvi è in mol ti ostinatezza, non picciolezza d'intendimento) che ad un poco di oblio delle cose già fatte, ad un po' d'istinto lasciato libero noi dobbiamo la Divina Commedia, il Decamerone, l'Orlando Furioso; e che dire ad ogni proposito: quello e questo de' nostri antichi hanno scritto in altra guisa equivale al dire: se il genio degli scrittori senti in passato l'influsso de' tempi, non lo ha da sentir più; se si distinse per qualità proprie e individuali, non si ha da distinguere più; se gli imitatori furon già gregge servile, giusta la nota frase di un poeta, che con pochi altri sta a capo d' una letteratura quasi tutta d'imitazione, ora sono gli unici, a cui possa attribuirsi buon senno.
Gran che! In tutte le arti belle si applaude ciò che reca diletto, e serve alle presenti opportunità, senza curar troppo se il bisogno de' nostri avi richiedeva da esse cose diverse; e nelle arti della parola si vorrebbe che si servisse a bisogni che più non esistono, anzichè ad altri che il tempo ha loro sostituiti. [...]
E un altro avvedimento mostra il Migliara, di cui quind'innanzi non vorrà mancare nemmeno il bravo Grossi, quello cioè di ricordarsi che scopo dell'arti imitative è il bello, il quale mai non può comporsi coll'orribile, massime soverchimente prolungato. Questo nostro riflesso cade principalmente su quel delirio dell'infelice Ildegonda, a cui par vedere l'amante (che avea giurato di apparirle ove a lei premorisse) fra i tormenti de' reprobi, imaginati dal Grossi con dantesca fantasia, ma tale che la nostra non riesce a sostenerla. Non era dunque possibile al suo talento poetico guidarci al funesto esito della visione con nostro minor raccapriccio? [...]
Chi trova ridicolo l'incontrarsi del primo raggio solare colla sacra ostia sollevata dal missionario in Atala troverà pur tale questo scontrarsi col volto dell'appena estinta vergine e rivestirlo di luce. I cuori impietositi, però, egualmente che i cuori infervorati sentono ne' più fortuiti incontri alcune, direi quasi misteriose relazioni, che altri non saprebbe imaginare; e al poeta ciò basta. Il sig. Dussaulx chiamò già in un luogo del giornale delle controversie (des debats) forzata e meschina l'idea di Chateaubriand; ma poi ritrattò il suo giudizio con una ingenuità che lo onora. E un altro critico di grido, censurandola come ricercata, e quindi contraria al sublime confessò almeno che era ingegnosa. Minor lode d'ingegno avrà il Grossi per la sua, poichè alquanto meno originale; ma anche minor biasimo di ricercatezza da chi avesse pur animo di non riconoscervi naturalezza bastante. Se non che, ove si proceda nelle cose della fantasia col regolo di una fredda ragione, dubito che possa trovar grazia l'istesso cigno di Valchiusa, che narrando la morte della sua donna, così fa dire alla schiera delle compagne venuta intorno al casto suo letto per saper s'esser può morte pietosa:
Lo spirto per partir di quel bel seno Con tutte sue virtuti in se romito Fatt'avea in quella parte il ciel sereno.
Certo nemmeno questa imaginazione si presenta facilmente allo spirito; ma quegli che ebbe Laura per vera mortal dea; che la credè colta da morte come il più bel fiore del mondo, non già per odio ma per dimostrarsi – più chiaramente nelle cose eccelse; l'innamorato Petrarca insomma potè figurarsi il portento, di cui canta la sua terzina.
Rimarrebbe a dirsi alcuna parola dell'effetto morale della novella; ma noi crediamo che ciascuno il senta abbastanza; e che, per quanta voglia si abbia di imprimerle il marchio d'una setta letteraria poco benevisa, si farà gran differenza fra essa e l'Eleonora di Burger, ed altre siffatte fantasie boreali, atte soltanto a fomentare le popolari superstizioni, mentre l'Ildegonda ha piuttosto efficacia di correggerle. Ma questo veramente è il minore suo pregio. L'epistola d'Eloisa ad Abelarde del Pope; quella d'una monaca al re di Danimarca del Pindemonte (che non si vorranno, credo, chiamare composizioni romantiche) dipingendo il contrasto di religiosi doveri e di umane passioni, e facendo trionfar gli uni sopra le altre, lasciano nell'anima la persuasione della sua forza in quegli incontri stessi in cui sarebbe più scusabile il credere di non possederla. L'Ildegonda rappresentando il sagrificio dell'innocenza alle avare o ambiziose ragioni di famiglia, le quali traggono dalla religione un aiuto, che questa abborre di prestar loro, fa sentire il prezzo de' lumi, che impediscono si orribili attentati, e mentre alle famiglie risparmiano delitti, preservano ciò che avvi di più venerabile in sulla terra dalla più indegna profanazione. Se non che, prescindendo da ogni altro vantaggio credo che mai non sia vano il commovere gli animi a profonda pietà; e pare che in queste commozioni, qual che ne sia la causa, il secolo si compiaccia. Quindi il salice piangente, sotto cui il sig. Grossi è uso di prendere le sue poetiche ispirazioni, è non tanto l'albero de' genj malinconici, come de' genj più cari alle Muse, e il compagno quasi indivisibile del decantato alloro.
M.
