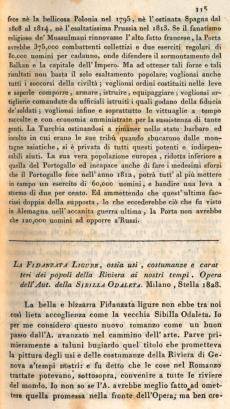
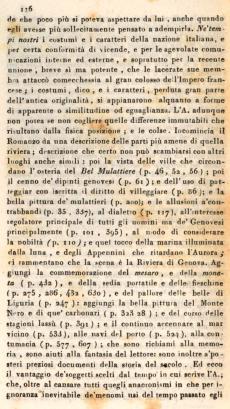
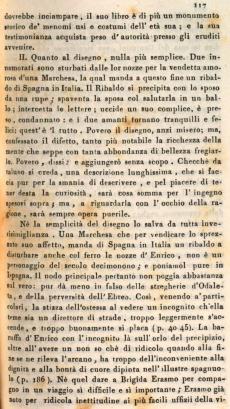
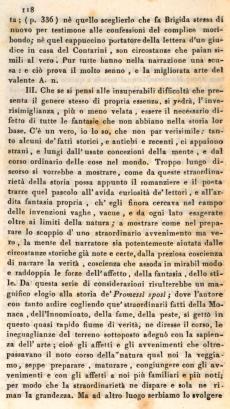

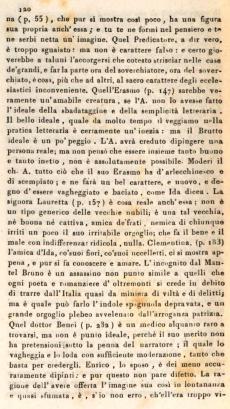
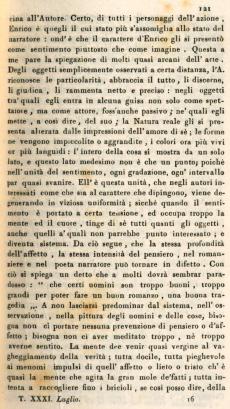
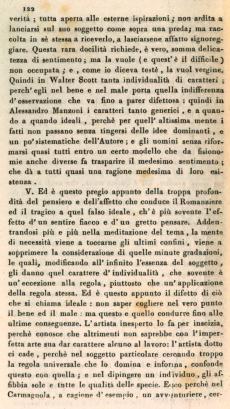
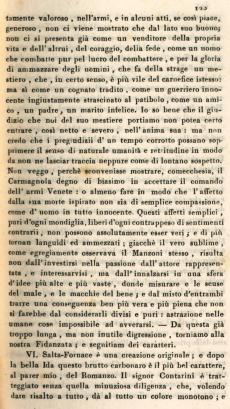

LA FIDANZATA LIGURE, ossia usi, costumanze e caratteri dei popoli della Riviera ai nostri tempi. Opera dell'Aut. della SIBILLA ODALETA. Milano, Stella 1828.
La bella e bizzarra Fidanzata ligure non ebbe tra noi così lieta accoglienza come la vecchia Sibilla Odaleta. Io per me considero questo nuovo romanzo come un buon passo dall'A. avanzato nel cammino dell'arte. Parve primieramente a taluni bugiardo quel titolo che prometteva la pittura degli usi e delle costumanze della Riviera di Genova a' tempi nostri: e fu detto che le cose nel Romanzo trattate potevano, sottosopra, convenire a tutte le riviere del mondo. lo non so se l'A. avrebbe meglio fatto ad omettere quella promessa nella fronte dell'Opera; ma ben credo che poco più si poteva aspettare da lui, anche quando egli avesse più sollecitamente pensato a adempirla. Ne' tempi nostri i costumi e i caratteri della nazione italiana, e per certa conformità di vicende, e per le agevolate comunicazioni interne ed esterne, e sopratutto per la recente unione, breve sì ma potente, che le lacerate sue membra attaccò comecchessia al gran colosso dell'Impero francese; i costumi, dico, e i caratteri, perduta gran parte dell'antica originalità, si appianarono alquanto a forme di apparente o similitudine od eguaglianza. L'A. adunque non potea se non cogliere quelle differenze immutabili che risultano dalla fisica posizione; e le colse. [...] Ed ecco il vantaggio de' soggetti scelti dal tempo in cui scrive l'A.; che, oltre al cansare tutti quegli anacronismi in che per ignoranza inevitabile de' menomi usi del tempo passato egli dovrebbe inciampare, il suo libro è di più un monumento storico de' menomi usi e costumi dell'età sua; e la sua testimonianza acquista peso d'autorità presso gli eruditi avvenire.
II. Quanto al disegno, nulla più semplice. Due innamorati sono sturbati dalle lor nozze per la vendetta amorosa d'una Marchesa, la qual manda a questo fine un ribaldo di Spagna in Italia. Il Ribaldo si precipita con lo sposo da una rupe; spaventa la sposa col salutarla in un ballo; intercetta le lettere; uccide un suo complice, è preso, condannato: e i due amanti tornano tranquilli e felici: quest'è 'l tutto. Povero il disegno, anzi misero; ma, confessato il difetto, tanto più notabile la ricchezza della mente che seppe con tanta abbondanza di bellezza fregiarlo. Povero, dissi: e aggiungerò senza scopo. Checché da taluno si creda, una descrizione lunghissima, che si faccia pur per la smania di descrivere, e pel piacere di tener desta la curiosità, sarà cosa somma per l'ingegno spesovi sopra; ma, a riguardarla con l' occhio della ragione, sarà sempre opera puerile.
Né la semplicità del disegno lo salva da tutta inverisimiglianza. Una Marchesa che per vendicare lo sprezzato suo affetto, manda di Spagna in Italia un ribaldo a disturbare anche col ferro le nozze d'Enrico, non è un personaggio del secolo decimonono; e poniamol pure in Ispagna. Il nodo principale pertanto non poggia abbastanza sul vero: pur dà meno in falso delle stregherie d'Odaleta, e della perversità dell'Ebreo. [...]
III. Che se si pensi alle insuperabili difficoltà che presenta il genere stesso di propria essenza, si vedrà, l'inverisimiglianza, più o meno velata, essere il necessario difetto di tutte le fantasie che non abbiano nella storia lor base. C'è un vero, io lo so, che non par verisimile: tanto alcuni de' fatti storici, e antichi e recenti, ci appaiono strani, e lungi dall'usate concezioni della mente, e dal corso ordinario delle cose nel mondo. Troppo lungo discorso si vorrebbe a mostrare, come da queste straordinarietà della storia possa appunto il romanziere e il poeta trarre quel pascolo all'avida curiosità de' lettori, e all'ardita fantasia propria, ch'egli finora cercava nel campo delle invenzioni vaghe, vacue, e da ogni lato esagerate oltre ai limiti della natura; a mostrare come nel preparare lo scoppio d'uno straordinario avvenimento ma vero, la mente del narratore sia potentemente aiutata dalle circostanze storiche già note e certe, dalla preziosa coscienza di narrare la verità, coscienza che assoda in mirabil modo e raddoppia le forze dell'affetto, della fantasia, dello stile. Da questa serie di considerazioni risulterebbe un magnifico elogio alla storia de' Promessi sposi; dove l'autore con tanto ardire cogliendo que' straordinarii fatti della Monaca, dell'Innominato, della fame, della peste, si gettò in questo quasi rapido fiume di verità, ne diresse il corso, le ineguaglianze del terreno sottoposto adeguò con la sapienza dell' arte; cioè gli affetti e gli avvenimenti che oltrepassavano il noto corso della natura qual noi la veggiamo, seppe preparare, maturare, congiungere con gli avvenimenti e con gli affetti a noi più familiari e più noti, per modo che la straordinarietà ne dispare e sola ne riman la grandezza. Ma ad altro luogo serbiamo lo svolgere quest'idea: qui, concesso che il Vero storico ha spesso dello strano tanto, che audacia parrebbe il voler farne soggetto a poesia, soggiungiamo che sola la storia può salvare dalla turpe macchia della inverisimiglianza la concezione de' fatti, qual'ella s'opera nella imaginazione dell'uomo. lo non prendo di ciò gli esempi né dagli sguaiati romanzi del secolo passato; e né meno dal gran fecondatore della Bellezza storica, Walter Scott, che nella parte inventiva tante volte e cosi visibilmente trascende i confini d'ogni verisimiglianza: io rammento i Promessi sposi; e le furberie con che Agnese trae fuor di casa Perpetua a quell'ora nel mese di novembre; e la tanta timidità di Lucia che si tiene sospesa, intantochè D. Abbondio ha il tempo di rovesciare e calamaio e lucerna, e quel mirabile accordarsi di circostanze tutte nel punto che il Sacrestano suona dal campanile a martello; e, oltre parecchie altre cose di simil genere, la gran disarmonia di caratteri, di affetti, di tuono, ch'è tra la parte inventata e la parte storica di quell'insigne lavoro. Questo dunque si pongano bene in mente i romanzieri novelli: che senza il sussidio della storia, oltre all'esagerazione de' caratteri, all'indeterminato delle descrizioni, al vago delle fantasie, s' ha, ch'è il peggio, l'inverisimile del disegno. Di che quando il lettore comincia ad accorgersi, le più splendide bellezze, se pur talora non si convertono in macchie, gli appaiono languide e inefficaci; e i più vivi affetti, non gli scendono al cuore. Ora ognun vede, che più noi cresciamo in civiltà, vale a dire, in senno, più questo difetto si fa visibile, e offende. Le fiabe sono pe' barbari, e pe' fanciulli.
IV. Ma quanto più gravi sono le imperfezioni del genere, tant'è più da ammirarsi la forza dell'ingegno che poté superarle. E questa forza l'A. n. dimostra principalmente ne' caratteri, ch'era la parte più debole del primo romanzo; ed è forse di questo la principale bellezza. Quell'ostessa, sebbene a taluni (p. 25) paja sostener troppo lunga e troppo notabil parte nel Dramma, pure ha un carattere molto spiccato e veramente suo: quella piccola Violantina (p. 55), che pur si mostra così poco, ha una figura sua propria anch'essa; e tu te ne formi nel pensiero e te ne serbi netta un'imagine. Quel Predicatore, a dir vero, è troppo sguaiato: ma non è carattere falso: e certo gioverebbe a taluni l'accorgersi che cotesto strisciar nelle case de' grandi, e far la parte ora del soverchiatore, ora del soverchiato, è cosa, più che ad altri, al sacro carattere degli ecclesiastici inconveniente. Quell'Erasmo (p. 147) sarebbe veramente un'amabile creatura, se l'A. non lo avesse fatto l'ideale della sbadataggine e della semplicità letteraria. Il bello ideale, quale da molto tempo il veggiamo nella pratica letteraria è certamente un'inezia: ma il Brutto ideale è un po' peggio. L'A. avrà creduto dipingere una persona reale; ma non pensò che essere insieme tanto buono e tanto inetto, non è assolutamente possibile. Moderi il ch. A. tutto ciò che il suo Erasmo ha d' arlecchinesco e di scempiato; e ne farà un bel carattere, e nuovo, e degno d'essere vagheggiato e baciato, come Ida dicea. La signora Lauretta (p. 157) è cosa reale anch'essa; non è un tipo generico delle vecchie nubili; è una tal vecchia, né buona né cattiva, amica de' frati, nemica di chiunque irriti un poco il suo irritabile orgoglio; che fa il bene e il male con indifferenza: ridicola, nulla. Clementina, (p. 183) l'amica d'Ida, co' suoi fiori, co' suoi uccelletti, ci si mostra appena, e pur si fa conoscere e amare. L'incognito dal Mantel Bruno è un assassino non punto simile a quelli che ogni poeta e romanziere d'oltremonti si crede in debito di trarre dall'Italia quasi da miniera di viltà e di delitti; ma è quale può farlo l'indole spagnuola depravata, e un grande orgoglio plebeo avvelenato dall'arroganza patrizia. Quel dottor Benci (p. 232) è un medico alquanto raro a trovarsi, ma non è punto ideale, perché il suo merito non ha pretensioni sotto la penna del narratore; il quale lo vagheggia e lo loda con sufficiente moderazione, tanto che basta per credergli. Enrico, lo sposo, è dei meno accuratamente dipinti: e pur questo non pare difetto. La ragione dell'avere offerta l'imagine sua così in lontananza e quasi sfumata, è, s'io non erro, ch'ell'era troppo vicina all'Autore. Certo, di tutti i personaggi dell' azione Enrico è quegli il cui stato più s'assomiglia allo stato del narratore: ond'è che il carattere d'Enrico gli si presentò come sentimento piuttosto che come imagine. Questa a me pare la spiegazione di molti quasi arcani dell' arte. Degli oggetti semplicemente osservati a certa distanza, l'A. riconosce le particolarità, abbraccia il tutto, li discerne, li giudica, li rammenta netto e preciso: negli oggetti tra' quali egli entra in alcuna guisa non solo come spettatore, ma come attore, foss'anche passivo; ne' quali egli mette, a cosi dire, del suo; la Natura reale gli si presenta alterata dalle impressioni dell'amore di sè; le forme ne vengono impiccolite o aggrandite, i colori ora più vivi or più languidi: l'intero della cosa si mostra da un solo lato, e questo lato medesimo non è che un punto; poiché nell'unità del sentimento, ogni gradazione, ogn' intervallo par quasi svanire. Ell'è questa unità, che negli autori interessati come che sia al carattere che dipingono, viene degenerando in viziosa uniformità; sicché quando il sentimento è portato a certa tensione, ed occupa troppo la mente ed il cuore, tinge di sé tutti quanti gli oggetti anche quelli a' quali non parrebbe punto interessato; e diventa sistema. Da ciò segue, che la stessa profondità dell'affetto, la stessa intensità del pensiero, nel romanziere e nel poeta narratore può tornare in difetto. Con ciò si spiega un detto che a molti dovrà sembrar paradosso: "che certi uomini son troppo buoni, troppo grandi per poter fare un buon romanzo, una buona tragedia". A non lasciarsi predominar dal sistema, nell' osservazione, nella pittura degli uomini e delle cose, bisogna non ci portare nessuna prevenzione di pensiero o d'affetto; bisogna non ci aver meditato troppo, né troppo averne sentito. La mente dee venir quasi vergine al vagheggiamento della verità; tutta docile, tutta pieghevole ai menomi impulsi di quell'affetto o lieto o tristo ch'è quasi la mente che agita la gran mole de' fatti; tutta intenta a raccogliere fino i bricioli, se così posso dire, della verità; tutta aperta alle esterne ispirazioni; non ardita a lanciarsi sul suo soggetto come sopra una preda; ma raccolta in sè stessa a riceverlo, a lasciarsene affatto signoreggiare. Questa rara docilità richiede, è vero, somma delicatezza di sentimento; ma la vuole (e quest'è il difficile) non occupata; e, come io diceva testé, la vuol vergine. Quindi in Walter Scott tanta individualità di caratteri; perch'egli nel bene e nel male porta quella indifferenza d'osservazione che va fino a parer difettosa: quindi in Alessandro Manzoni i caratteri tanto generici, e a quando a quando ideali, perché per quell'altissima mente i fatti non passano senza tingersi delle idee dominanti, e un po' sistematiche dell'Autore; e gli uomini senza riformarsi quasi tutti entro un certo modello che da fisionomie anche diverse fa trasparire il medesimo sentimento; che dà a tutti quasi una ragione medesima di loro esistenza.
V. Ed è questo pregio appunto della troppa profondità del pensiero e dell'affetto che conduce il Romanziere ed il tragico a quel falso ideale, ch'è più sovente l'effetto d'un sentire fiacco e d'un gretto pensare. Addentrandosi più e più nella meditazione del tema, la mente di necessità viene a toccarne gli ultimi confini, viene a sopprimere la considerazione di quelle minute gradazioni, le quali, modificando all'infinito l'essenza del soggetto gli danno quel carattere d'individualità, che sovente è un'eccezione alla regola, piuttosto che un'applicazione della regola stessa. Ed è questo appunto il difetto di ciò che si chiama ideale: non saper cogliere nel vero punto il bene ed il male: ma questo e quello condurre fino alle ultime conseguenze. L'artista inesperto lo fa per inscizia, perché conosce che altrimenti non saprebbe con l'imperfetta arte sua dar carattere alcuno al lavoro: l'artista dotto ci cade, perché nel soggetto particolare cercando troppo la regola universale che lo domina e informa, confonde questo con quella; e nel dipingere un individuo, gli affibbia sole e tutte le qualità delle specie. Ecco perché nel Carmagnola, a cagione d'esempio, un avventuriere, certamente valoroso, nell'armi, e in alcuni atti, se così piace, generoso, non ci viene mostrato che dal lato suo buono; non ci si presenta già come un venditore della propria vita e dell' altrui, del coraggio, della fede, come un uomo che combatte pur pel lucro del combattere, e per la gloria di ammazzare degli uomini, che fa della strage un mestiero, che, in certo senso, è più vile del carnefice istesso: ma sì come un cognato tradito, come un guerriero innocente ingiustamente strascinato al patibolo, come un amico, un padre, un marito infelice. lo so bene che il giudizio che noi del suo mestiere portiamo non potea certo entrare, così netto e severo, nell'anima sua: ma non credo che i pregiudizii d' un tempo corrotto possano sopprimere il senso di naturale umanità e rettitudine in modo da non ne lasciar traccia neppure come di lontano sospetto. Non veggo, perché sconvenisse mostrare, comecchesia, il Carmagnola degno di biasimo in accettare il comando dell'armi Venete: o almeno fare in modo che l'affetto dalla sua morte ispirato non sia di semplice compassione, come d'uomo in tutto innocente. Questi affetti semplici, puri d'ogni mondiglia, liberi d'ogni contrappeso di sentimenti contrarii, non possono assolutamente esser veri; e di più tornan languidi ed ammezzati; giacché il vero sublime come egregiamente osservava il Manzoni stesso, risulta non dall'investirsi nella passione dall'attore rappresentata, e interessarvisi, ma dall'innalzarsi in una sfera d'idee più alte e più vaste, donde misurare e le scuse del male, e le macchie del bene; e dal misto d'entrambi trarre una conseguenza ben più vera e più piena che non si farebbe dal considerarli divisi e puri: astrazione nelle umane cose impossibile ad avverarsi. [...]
Un difetto essenziale gli resta, difetto che investe tutto da capo a fondo il lavoro, e ne appanna ogni luce; ed è l'inconvenienza del tuono. L'A. vuole, a dispetto del tema, mostrarsi sempre faceto, allegroccio, ingegnoso; i suoi sali li tira sovente da allusioni erudite; stiracchia i suoi epigrammi con affettazione manifesta che spiace. Non è del suo ingegno la colpa, io lo so: ma è della società nella quale egli vive. L'Italia non conosce punto il linguaggio de la bonne compagnie; ond'è che sovente l'originalità dello spirito nostro degenera in pedanteria, o in isciocchezza. Di ciò s'hanno gli esempi, anche in libri più celebri: né riparo ci resta altro che la lettura de' libri migliori, massimamente francesi, e lo studio di quella lingua parlata che più si presta a certa elegante naturalezza di spirito, a certa semplice delicatezza di tuono.
K. X. Y.
