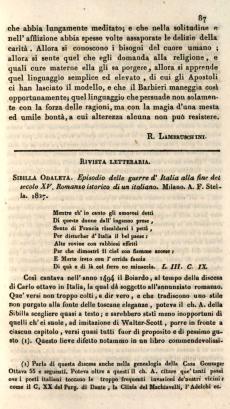
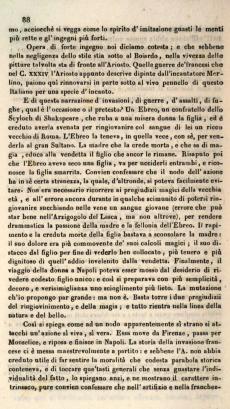
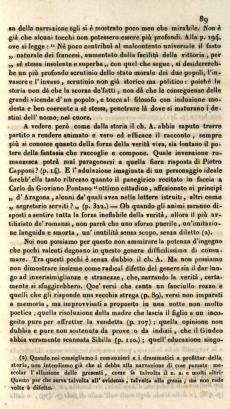
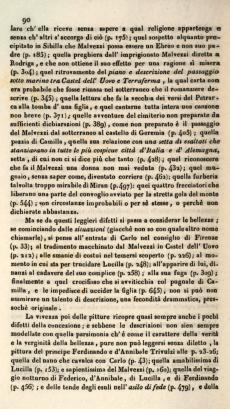
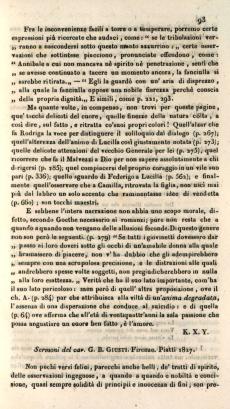
SIBILLA ODALETA. Episodio delle guerre d'Italia alla fine del secolo XV. Romanzo istorico di un italiano. Milano. A. F. Stella. 1827.
Mentre ch'io cauto gli amorosi detti
Di queste donne dall'inganno prese,
Sento di Francia riscaldarsi i petti,
Per disturbar d'Italia il bel paese:
Alte rovine con rabbiosi effetti
Par che dimostri il ciel con fiamme accese:
E Marte irato con l'orrida faccia
Di quà e di là col ferro ne minaccia. L. III. C. IX.
Così cantava nell'anno 1494 il Boiardo, al tempo della discesa di Carlo ottavo in Italia, la qual dà soggetto all'annunziato romanzo. Que' versi non troppo colti, a dir vero, e che tradiscono uno stile non purgato alla fonte delle toscane eleganze, poteva il ch. A. della Sibilla scegliere quasi a testo; e sarebbero stati meno inopportuni di quelli ch'ei suole, ad imitazione di Walter-Scott, porre in fronte a ciascun capitolo, versi quasi tutti fuor di proposito e di pessimo gusto (I). Questo lieve difetto notammo in un libro commendevolissimo, acciocché si vegga come lo spirito d'imitazione guasti le menti più rette e gl'ingegni più forti.
Opera, di forte ingegno noi diciamo cotesta; e che sebbene nella negligenza dello stile stia sotto al Boiardo, nella vivezza delle pitture talvolta sta di fronte all'Ariosto. Quelle guerre de' francesi che nel C. XXXIV l'Ariosto appunto descrive dipinte dall'incantatore Merlino, paiono qui rinnovarsi in parte sotto al vivo pennello di questo Italiano per una specie d'incanto.
E di questa narrazione d'invasioni, di guerre, d'assalti, di fughe, qual è l'occasione o il pretesto? Un Ebreo, un confratello dello Scyloch di Shakspeare, che ruba a una misera donna la figlia, ed è creduto averla svenata per ringiovanire col sangue di lei un ricco vecchio di Roma. L'Ebreo la teneva, in quella vece, con sé, per venderla al gran Sultano. La madre che la crede morta, e che sa di magia, educa alla vendetta il figlio che ancor le rimane. Risaputo poi che l'Ebreo aveva seco una figlia, va per ucciderli entrambi, e riconosce le figlia smarrita. Convien confessare che il nodo dell'azione ha in sé certa stranezza, la quale, d'altronde, si poteva facilmente evitare. Non era necessario ricorrere ai pregiudizii magici della vecchia età, e all'errore ancora durante in qualche scimunito di potersi ringiovanire succhiando nelle vene un sangue giovane (errore che può star bene nell'Arzigogolo del Lasca, ma non altrove), per rendere drammatica la passione della madre e la fellonia dell'Ebreo. Il rapimento e la creduta morte della figlia bastava a sconsolare la madre: il suo dolore era più commovente de' suoi calcoli magici; il suo distacco dal figlio per fine di vederlo ben collocato, più tenero e più dignitoso di quell'addio invelenito dalla vendetta. Finalmente, il viaggio della donna a Napoli poteva esser mosso dal desiderio di rivedere codesto figlio unico: e così si preparava con più semplicità, decoro, e verisimiglianza uno scioglimento più lieto. La mutazione ch'io propongo par grande: ma non è. Basta torre i due pregiudizio del ringiovinimento, e della magia; e tutto rientra nella linea della natura e del bello.
Così si spiega come ad un nodo apparentemente sì strano si attacchi un'azione sì viva, sì vera. Essa move da Firenze, passa per Monselice, e riposa e finisce in Napoli. La storia della invasione francese ci è messa maestrevolmente a partito: e sebbene l'A. non abbia creduto utile di far sentire la moralità che codesta parabola storica conteneva, e di toccare que' tasti generali che senza guastare l'individualità del fatto, lo spiegano anzi, e ne mostrano il carattere intrinseco, pure convien confessare che nell'artifizio e nella franchezza della narrazione egli si è mostrato poco men che mirabile. Non è già che alcuni tocchi non potessero essere più profondi. Alla p. 194, ove si legge: "Né poco contribuì al malcontento universale il fasto naturale dei francesi, aumentato dalla facilità della vittoria, per sé stessa insolente e superba" con quel che segue, si desidererebbe un più profondo scrutinio dello stato morale dei due popoli, l'invasore e l'invaso, scrutinio non già storico ma politico: poiché la storia non dà che la scorza de' fatti, non dà che le conseguenze delle grandi vicende d'un popolo, e tocca al filosofo con induzione modesta e ben coerente a sé stessa, penetrare là dove si maturano i destini dell'uomo; nel cuore.
A vedere però come dalla storia il ch. A. abbia saputo trarre partito a rendere animato e vero ed efficace il racconto, sempre più si conosce quanto della forza della verità viva, sia lontano il potere della fantasia che raccoglie e compone. Quale invenzione romanzesca potrà mai paragonarsi a quella fiera risposta di Pietro Capponi? (p. 14). E l'adulazione imaginata di un personaggio ideale farebbe ella tanto ribrezzo quanto il panegirico recitato in faccia a Carlo da Gioviano Pontano "ottimo cittadino, affezionato ai principi d'Aragona, alcuni de' quali avea nelle lettere istruiti, altri come segretario serviti?" (p. 322.) — Oh quando gli animi saranno disposti a sentire tutta la forza ineffabile della verità, allora il più artifiziato de' romanzi, non parrà che uno sforzo puerile, un'imitazione languida e smorta, un'inutilità senza scopo, senza diletto (2).
Noi non possiamo per questo non ammirare la potenza d'ingegno che pochi valenti degnano in questo genere difficilissimo di consumare. Tra questi pochi è senza dubbio il ch. A. Ma non possiamo non dimostrare insieme come radical difetto del genere sia il dar luogo ad inverisimiglianze e stranezze, che, narrando la verità, certamente si sfuggirebbero. Que' versi che canta un fanciullo rozzo e quelli che gli risponde una vecchia strega (p. 89), versi non imparati a memoria, ma improvvisati a proposito in una notte non molto poetica; quella risoluzione della madre che lascia il figlio a un incognito pure per affrettar la vendetta (p. 107); quella opinione non dubbia e pure non sostenuta da prove o da indizii, che il Giudeo abbia veramente scannata Sibilla (p. 110.); quell'educazione singolare ch'ella riceve senza sapere a qual religione appartenga e senza ch'altri s'accorga di ciò (p. 175); quel sospetto alquanto precipitato in Sibilla che Malvezzi possa essere un Ebreo e non suo padre (p. 185); quella preghiera dall'imprigionato Malvezzi diretta a Rodriga, e che non ottiene il suo effetto per una ragione sì misera (p. 304); quel ritrovamento del piano e descrizione del passaggio sotto marino tra Castel dell'Uovo e Terraferma, la qual carta non era probabile che fosse rimasa nel sotterraneo che il romanziere descrive (p. 345); quella lettura che fa la vecchia dei versi del Petrarca alla tomba d'una figlia, e quel cantarne tutta intera una canzone non breve (p. 371), quelle avventure del cimiterio non preparate da sufficienti dichiarazioni (p. 389), come non preparato è il passaggio del Malvezzi dal sotterraneo al castello di Geremia (p. 405); quella pazzia di Camilla, quella sua relazione con una setta di esaltati che stanziavano in tutte le più cospicue città d'Italia e d'Alemagna, setta, di cui non ci si dice più che tanto (p. 428); quel riconoscere che sa il Malvezzi una donna non mai veduta (p. 432); quel mugnaio, senza saper come, diventato corriere (p. 462); quella furberia talvolta troppo mirabile di Miran (p.497): quei quattro frecciatori che liberano una parte del convoglio avviato per la stretta gola del monte (p. 544); son circostanze improbabili o per sé stesse, o perché non dichiarate abbastanza.
[...]
E sebbene l'intera narrazione non abbia uno scopo morale, difetto, secondo Goethe necessario ai romanzi; pure non resta che a quando a quando non vengano delle allusioni feconde. Di questo genere non son però le seguenti. (p. 279) "Se tutti i giovinetti dovessero dar passo ai loro doveri sotto gli occhi di un'amabile donna alla quale bramassero di piacere, non v'ha dubbio che gli adempirebbero sempre con una scrupolosa precisione, e le distrazioni alle quali andrebbero spesse volte soggetti, non pregiudicherebbero in nulla alla loro esattezza." Verità che ha il suo lato importante, com'ha il suo lato pericoloso: men però di quell'altra proposizione, ove il ch. A. (p. 284) par che attribuisca alla viltà di un'anima degradata, l'assenza di una disperazione che conduce al suicidio: e di quella (p. 64) ove afferma che all'età di ventiquattr'anni la sola passione che possa angustiare un cuore ben fatto, è l'amore.
K. X. Y.
(I) Parla di questa discesa anche nella genealogia della Casa Gonzaga: Ottava 55 e seguenti. Poteva oltre a questi il ch. A. citare que' tanti passi ove i poeti italiani toccano le troppo frequenti invasioni de' nostri vicini: come il C. XX del Purg. di Dante, la Clizia del Machiavelli, l'Adelchi ec.
(2) Quando noi consigliamo i romanzieri e i drammatici a profitar della storia, non intendiamo già che si debba alla narrazione di cose passate mescolar l'allusione delle presenti, come fa talvolta il n. a. e molti altri. Questo par che serva talvolta all'evidenza, talvolta alla grazia; ma non rade volte è difetto.
