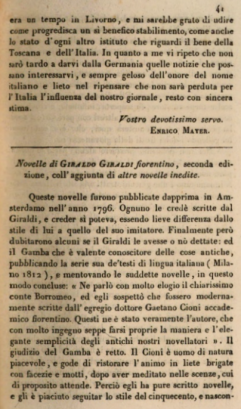
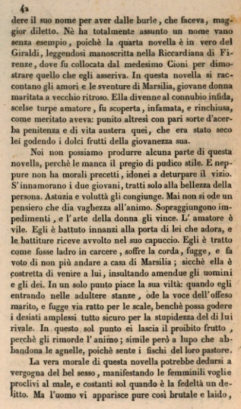
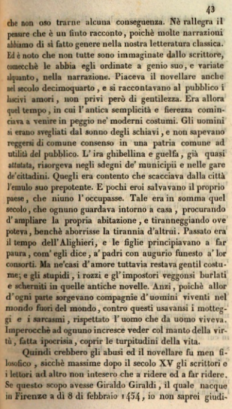
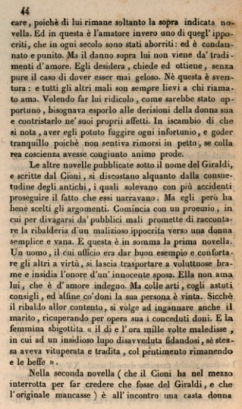
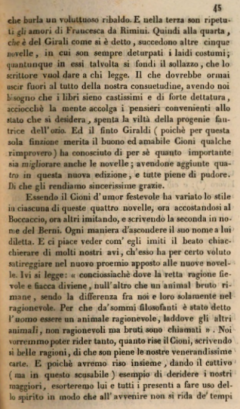
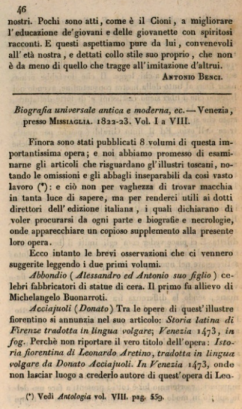
| Year | 1823 |
| Issue | 11A |
| Page(s) | 41-46 |
Novelle di GIRALDO GIRALDI fiorentino, seconda edizione, coll'aggiunta di altre novelle inedite.
Queste novelle furono pubblicate dapprima in Amsterdamo nell'anno 1796. Ognuno le credè scritte dal Giraldi, e creder si poteva, essendo lieve differenza dallo stile di lui a quello del suo imitatore. Finalmente però dubitarono alcuni se il Giraldi le avesse o nò dettate: ed il Gamba che è valente conoscitore delle cose antiche pubblicando la serie sua de' testi di lingua italiana (Milano 1812), e mentovando le suddette novelle, in questo modo concluse: "Ne parlò con molto elogio il chiarissimo conte Borromeo, ed egli sospettò che fossero modernamente scritte dall'egregio dottore Gaetano Cioni accademico fiorentino. Questi ne è stato veramente l'autore, che con molto ingegno seppe farsi proprie la maniera e l'elegante semplicità degli antichi nostri novellatori". Il giudizio del Gamba è retto. Il Cioni è uomo di natura piacevole, e gode di ristorare l'animo in liete brigate con facezie e motti, dopo aver meditato nelle scenze, cui di proposito attende. Perciò egli ha pure scritto novelle, e gli è piaciuto seguitar lo stile del cinquecento, e nascon-
dere il suo nome per aver dalle burle, che faceva, maggior diletto. Nè ha totalmente assunto un nome vano senza esempio, poichè la quarta novella è in vero del Giraldi, leggendosi manoscritta nella Riccardiana di Firenze, dove fu collocata dal medesimo Cioni per dimostrare quello che egli asseriva. In questa novella si raccontano gli amori e le sventure di Marsilia, giovane donna maritata a vecchio ritroso. Ella divenne al connubio infida, scelse turpe amatore, fu scoperta, infamata, e rinchiusa, come meritato aveva: punito altresì con pari sorte d'acerba penitenza e di vita austera quei, che era stato seco lei godendo i dolci frutti della giovanezza sua.
Noi non possiamo produrre alcuna parte di questa novella, perchè le manca il pregio di pudico stile. E neppure non ha morali precetti, idonei a deturpare il vizio. S'innamorano i due giovani, tratti solo alla bellezza della persona. Astuzia e voluttà gli congiunge. Mai non si ode un pensiero che dia vaghezza all'animo. Sopraggiungono impedimenti, e l'arte della donna gli vince. L'amatore è vile. Egli è battuto innanzi alla porta di lei che adora, e le battiture riceve avvolto nel suo capuccio. Egli è tratto come fosse ladro in carcere, soffre la corda, fugge, e fa voto di non più andare a casa di Marsilia; sicchè ella è costretta di venire a lui, insultando amendue gli uomini e gli dei. In un solo punto piace la sua viltà: quando egli entrando nelle adultere stanze, ode la voce dell'offeso marito, e fugge via ratto per le scale, benchè possa godere i desiati amplessi tutto sicuro per la stupidezza del di lui rivale. In questo sol punto ei lascia il proibito frutto perchè gli rimorde l'animo; simile però a lupo che abbandona le agnelle, poichè sente i fischi del loro pastore.
La vera morale di questa novella potrebbe dedursi a vergogna del bel sesso, manifestando le femminili voglie proclivi al male, e costanti sol quando è la fedeltà un delitto. Ma l'uomo vi apparisce pure così brutale e laido,
che non oso trarne alcuna conseguenza. Nè rallegra il pensare che è un finto racconto, poichè molte narrazioni abbiamo di sì fatto genere nella nostra letteratura classica. Ed è noto che non tutte sono immaginate dallo scrittore, comecchè le abbia egli ordinate a genio suo, e variate alquanto, nella narrazione. Piaceva il novellare anche nel secolo decimoquarto, e si raccontavano al pubblico i lascivi amori, non privi però di gentilezza. Era allora quel tempo, in cui l'antica semplicità e fierezza cominciava a venire in peggio ne' moderni costumi. Gli uomini si erano svegliati dal sonno degli schiavi, e non sapevano reggersi di comune consenso in una patria comune ad utilità del pubblico. L'ira ghibellina e guelfa, già quasi attutata, risorgeva negli sdegni de' municipii e nelle gare de' cittadini. Quegli era contento che scacciava dalla città l'emulo suo prepotente. E pochi eroi salvavano il proprio paese, che niuno l'occupasse. Tale era in somma quel secolo, che ognuno guardava intorno a casa, procurando d'ampliare la propria abitazione, e tiranneggiando ove poteva, benchè aborrisse la tirannia d'altrui: Passato era il tempo dell'Alighieri, e le figlie principiavano a far paura, com'egli dice, a' padri con augurio funesto a' lor consorti. Ma ne' casi d'amore tuttavia restava gentil costume; e gli stupidi, i rozzi e gl'impostori veggonsi burlati e scherniti in quelle antiche novelle. Anzi, poichè allor d'ogni parte sorgevano compagnie d'uomini viventi nel mondo fuori del mondo, contro questi usavansi i motteggi e i sarcasmi, rispettato l'uomo che da uomo viveva. Imperocchè ad ognuno incresce veder col manto della virtù, fatta ipocrisia, coprir le turpitudini della vita.
Quindi crebbero gli abusi ed il novellare fu men filosofico, sicchè massime dopo il secolo XV gli scrittori e i lettori ad altro non intesero che a ridere ed a far ridere. Se questo scopo avesse Giraldo Giraldi, il quale nacque in Firenze a di 8 di febbraio 1454, io non saprei giudi-
care, poichè di lui rimane soltanto la sopra indicata novella. Ed in questa è l'amatore invero uno di quegl'ippocriti, che in ogni secolo sono stati aborriti: ed è condannato e punito. Ma il danno sopra lui non viene da' tradimenti d'amore. Egli desidera, chiede ed ottiene, senza pure il caso di dover esser mai geloso. Nè questa è sventura: e tutti gli altri mali son sempre lievi a chi riamato ama. Volendo far lui ridicolo, come sarebbe stato opportuno, bisognava esporlo alle derisioni della donna sua e contristarlo ne' suoi proprii affetti. In iscambio di che si nota, aver egli potuto fuggire ogni infortunio, e goder tranquillo poichè non sentiva rimorsi in petto, se colla rea coscienza avesse congiunto animo prode.
Le altre novelle pubblicate sotto il nome del Giraldi, e scritte dal Cioni, si discostano alquanto dalla consuetudine degli antichi, i quali solevano con più accidenti proseguire il fatto che essi narravano. Ma egli però ha bene scelti gli argomenti. Comincia con un proemio; in cui per divagarsi da pubblici mali promette di raccontare la ribalderia d'un malizioso ippocrita verso una donna semplice e vana. E questa è in somma la prima novella. Un uomo, il cui ufficio era dar buon esempio e conforta re gli altri a virtù, si lascia trasportare a voluttuose brame e insidia l'onore d'un'innocente sposa. Ella non ama lui, che è d'amore indegno. Ma colle arti, cogli astuti consigli, ed alfine co' doni la sua persona è vinta. Sicchè il ribaldo allor contento, si volge ad ingannare anche il marito, ricuperando per opera sua i conceduti doni. E la femmina sbigottita "il dì e l'ora mille volte maledisse in cui ad un insidioso lupo disavveduta fidandosi, sè stessa aveva vituperata e tradita, col pentimento rimanendo e le beffe".
Nella seconda novella (che il Cioni ha nel mezzo interrotta per far credere che fosse del Giraldi, e che l'originale mancasse) è all'incontro una casta donna
che burla un voluttuoso ribaldo. E nella terza son ripetuti gli amori di Francesca da Rimini. Quindi alla quarta, che è del Girali come si è detto, succedono altre cinque novelle, in cui son sempre deturpati i laidi costumi; quantunque in essi talvolta si fondi il sollazzo, che lo scrittore vuol dare a chi legge. Il che dovrebbe ormai uscir fuori al tutto della nostra consuetudine, avendo noi bisogno che i libri sieno castissimi e di forte dettatura, acciocchè la mente accolga i pensieri convenienti allo stato che si desidera, spenta la viltà della progenie fautrice dell'ozio. Ed il finto Giraldi (poichè per questa sola finzione merita il buono ed amabile Cioni qualche rimprovero) ha conosciuto di per sè quanto importante sia migliorare anche le novelle; avendone aggiunte quatro in questa nuova edizione, e tutte piene di pudore. Di che gli rendiamo sincerissime grazie.
Essendo il Cioni d'umor festevole ha variato lo stile in ciascuna di queste quattro novelle, ora accostandosi al Boccaccio, ora altri imitando, e scrivendo la seconda in nome del Berni. Ogni maniera d'ascondere il suo nome a lui diletta. E ci piace veder com'egli imiti il beato chiacchierare di molti nostri avi, ch'esso ha per certo voluto satireggiare nel nuovo proemio apposto alle nuove novelle. Ivi si legge: "conciossiachè dove la retta ragione fievole e fiacca diviene, null'altro che un animal bruto rimane, sendo la differenza fra noi e loro solamente nel ragionevole. Per che da' sommi filosofanti è stato detto l'uomo essere un animale ragionevole, laddove gli altri animali, non ragionevoli ma bruti sono chiamati". Noi vorremmo poter rider tanto, quanto rise il Cioni, scrivendo sì belle ragioni, di che son piene le nostre venerandissime carte. E poichè avremo riso insieme, dando il cattivo (ma in questo scusabile) esempio di deridere i nostri maggiori, esorteremo lui e tutti i presenti a fare uso dello spirito in modo che all'avvenire non si rida de' tempi
nostri. Pochi sono atti, come è il Cioni, a migliorare l'educazione de' giovani e delle giovanette con spiritosi racconti. E questi aspettiamo pure da lui, convenevoli all'età nostra, e dettati collo stile suo proprio, che non è da meno di quello che tragge all'imitazione d'altrui.
ANTONIO BENCI.
