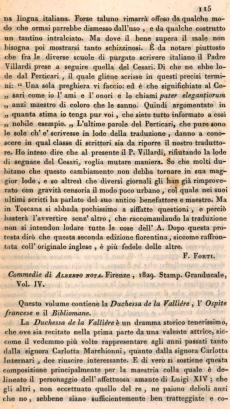
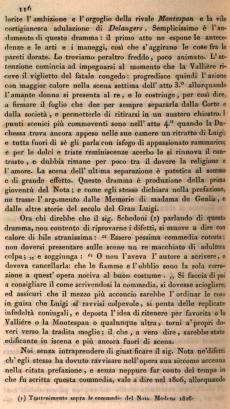
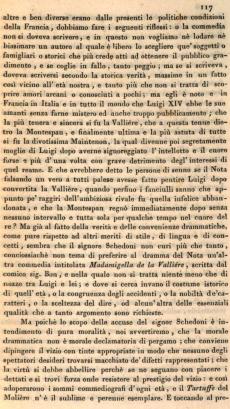
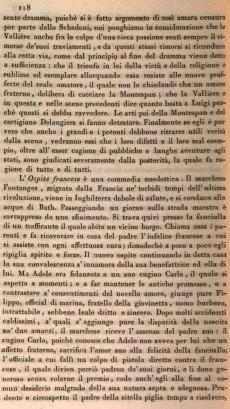
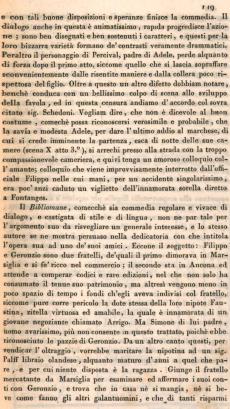
Commedie di ALBERTO NOTA. Firenze, 1829. Stamp. Granducale, Vol. IV.
Questo volume contiene la Duchessa de la Vallière, l'Ospite francese e il Bibliomane.
La Duchessa de la Vallière è un dramma storico tenerissimo, che ove sia recitato nella prima parte da una valente attrice, siccome il vedemmo più volte rappresentare agli anni passati tanto dalla signora Carlotta Marchionni, quanto dalla signora Carlotta Internari, dee riuscire interessante. E di vero si sostiene questa composizione principalmente per la maestria colla quale è delineato il personaggio dell'affettuosa amante di Luigi XIV; che gli altri, non eccettuato quello del re, ne paiono deboli anzi che no, sebbene siano sufficientemente ben tratteggiate e colorite l'ambizione e l'orgoglio della rivale Montespan e la vile cortigianesca adulazione di Delaugers. Semplicissimo è l'andamento di questo dramma: il primo atto ne espone le antecedenze e le arti e i maneggi, così che s'aggirano le cose fra le pareti dorate. Lo troviamo peraltro freddo, poco animato. L'attenzione comincia ad impegnarsi al momento che la Vallière riceve il viglietto del fatale congedo: progredisce quindi l'azione con maggior calore nella scena settima dell' atto 3.° allorquando l'amante donna si presenta al re, e lo costringe, per così dire, a firmare il foglio che dee per sempre separarla dalla Corte e dalla società, e permetterle di ritirarsi in un austero chiostro. I punti scenici più commoventi sono nell' atto 4.° quando la Duchessa trova ancora appeso nelle sue camere un ritratto di Luigi e tutta fuori di sè gli parla con isfogo di appassionato rammarico; e per le dolci e triste reminiscenze acerbo le si rinnova il contrasto, e dubbia rimane per poco tra il dovere la religione e l'amore. La scena dell'ultima separazione è patetica al sommo e di grande effetto. Questo dramma è produzione della prima gioventù del Nota; e come egli stesso dichiara nella prefazione, ne trasse l'argomento dalle Memorie di madama de Genlis, e dalle altre storie del secolo del Gran Luigi.
Ora chi direbbe che il sig. Schedoni (I) parlando di questo dramma, non contento di riprovarne i difetti, si muove a dire con calore di bile stranissima: "Essere pessima commedia cotesta; non doversi presentare sulle scene un re macchiato di adultera colpa;" e soggiunga: "O non l'aveva l'autore a scrivere, o doveva cancellarla: che le fiamme e l'obblio sono la sola correzione a quest'opera nociva al buon costume." Si faccia di poi a consigliare il come scrivendosi la commedia, si dovesse sciogliere; ed assicuri che il mezzo più acconcio sarebbe l'ordinar le cose in guisa che Luigi si ravvisi colpevole, si penta delle replicate infedeltà coniugali, e deposta l'idea di ritenere per favorita o la Vallière o la Montespan o qualunque altra, torni a' propri doveri verso la tradita moglie; il che, a vero dire, sarebbe stato edificante in iscena e più ancora fuori di scena.
Noi senza intraprendere di giustificare il sig. Nota ne' difetti ch'egli stesso ha dovuto ravvisare nell'opera sua siccome accenna nella citata prefazione, e senza neppure far conto del tempo in che fu scritta questa commedia, vale a dire nel 1806, allorquando altre e ben diverse erano dalle presenti le politiche condizioni della Francia, dobbiamo fare i seguenti riflessi: o la commedia non si doveva scrivere, e in questo non vogliamo né lodare né biasimare un autore al quale è libero lo scegliere que' soggetti o famigliari o storici che più crede atti ad ottenere il pubblico gradimento, e se coglie in fallo, tanto peggio; ma se si scriveva doveva scriversi secondo la storica verità, massime in un fatto così vicino all'età nostra, e tanto più che non si tratta di scoprire amori arcani o conosciuti a pochi; ma egli è noto e in Francia in Italia e in tutto il mondo che Luigi XIV ebbe le sue amanti senza farne mistero ed anche troppo pubblicamente; che la più tenera e sincera si fu la Vallière, che a questa tenne dietro la Montespan, e finalmente ultima e la più astuta di tutte si fu la divotissima Maintenon, la qual divenne poi segretamente moglie di Luigi dopo averne signoreggiato l'intelletto e il cuore forse e più d'una volta con grave detrimento degl'interessi di quel reame. E che avrebbero detto le persone di senno se il Nota falsando un vero a tutti palese avesse fatto pentire Luigi dopo convertita la Vallière, quando perfino i fanciulli sanno che appunto pe' raggiri dell'ambiziosa rivale fu quella infelice abbandonata, e che la Montespan regnò immediatamente dopo senza nessuno intervallo e tutta sola per qualche tempo nel cuore del re? Ma già al fatto della verità e delle convenienze drammatiche, come pure rispetto ad altri meriti di stile, di lingua e di concetti, sembra che il signore Schedoni non curi più che tanto, conciossiachè non tema di preferire al dramma del Nota un'altra commedia intitolata Madamigella de la Vallière, scritta dal comico sig. Bon, e nella quale non si tratta niente meno che di nozze tra Luigi e lei; e dove si cerca invano il costume istorici di quell' età, o la congruenza degli accidenti, o la nobiltà de' caratteri, o la sceltezza del dire, od alcun'altra delle essenziali qualità che a tanto argomento sono richieste.
Ma poichè lo scopo delle accuse del signor Schedoni è intendimento di pura moralità, noi avvertiremo, che la morale drammatica non è morale declamatoria di pergamo; che conviene dipingere il vizio con tinte appropriate in modo che nessuno degli spettatori desideri trovarsi macchiato de' difetti rappresentati; che la virtù si debbe abbellire perchè se ne seguano con piacere i dettati e si trovi forza onde resistere al prestigio del vizio: e così adoperarono i sommi commediografi d'ogni età, e il Tartuffe del Molière n'è il sublime e perenne esemplare. E toccando al presente dramma, poichè si è fatto argomento di così amara censura per parte dello Schedoni, noi ponghiamo in considerazione che la Vallière anche fra le colpe d'una cieca passione sentì sempre il rimorso de' suoi traviamenti, e da questi stessi rimorsi si riconduce alla retta via, come dal principio al fine del dramma viene detto a sufficienza: che il trionfo in lei della virtù e della religione è sublime ed esemplare allorquando essa resiste alle nuove profferte del reale amatore, il quale non le chiedendo che un amore fraterno, delibera di cacciare la Montespan; che la Vallière e in questa e nelle scene precedenti dice quanto basta a Luigi perchè questi si debba ravvedere. Le arti poi della Montespan e del cortigiano Delaugiers si fanno detestare. Finalmente se egli è pur vero che anche i grandi e i potenti debbono ritrarre utili verità dalla scena, vedranno essi che i loro difetti e il loro mal esempio, oltre all'esser cagione di pubbliche e lunghe sventure agli stati, sono giudicati severamente dalla posterità, la quale fa ragione di tutto e di tutti.
L'Ospite francese è una commedia anedottica. Il marchese Fontanges, migrato dalla Francia ne' torbidi tempi dell'ultima rivoluzione, viene in Inghilterra debole di salute, e si conduce alle acque di Bath. Passeggiando un giorno sulla strada maestra è sovrappreso da uno sfinimento. Si trova quivi presso la fanciulla di un trafficante il quale abita un vicino borgo. Chiama essa i parenti e fa ricoverare in casa del padre l'infelice francese a cui si assiste con ogni affettuosa cura; dimodochè a poco a poco egli ripiglia spirito e forze. Il nuovo ospite continuando in detta casa la sua convalescenza s'innamora della sua benefattrice ed ella di lui. Ma Adele era fidanzata a un suo cugino Carlo, il quale si aspetta a momenti; e a far mantener le antiche promesse, e a contrastare a' consentimenti del novello amore, giunge pure Filippo, official di marina, fratello della giovinetta, uomo burbero, intrattabile, sebbene leale dritto e sincero. Dopo molti accidenti caldissimi, a' quali s'aggiunge pure la disparità della nascita ne' due amanti, il marchese riceve l'assenso del padre suo: il cugino Carlo, poichè conosce che Adele non aveva per lui che un affetto fraterno, sacrifica l'amor suo alla felicità della fanciulla; l'officiale a cui fallì un colpo di pistola diretto contra il francese, il quale divien perciò padron de' suoi giorni, e li dona generoso senza volerne il premio, cede anch'egli alla fine al comun desiderio malgrado della sua natura aspra e sdegnosa. Prudente e circospetto il padre della zitella piglia tempo a risolvere, e con tali buone disposizioni e speranze finisce la commedia. Il dialogo anche in questa è animatissimo, rapida progredisce l'azione; sono ben disegnati e ben sostenuti i caratteri, e questi per la loro bizzarra varietà formano de' contrasti veramente drammatici. Peraltro il personaggio di Percival, padre di Adele, perde alquanto di forza dopo il primo atto, siccome quello che si lascia sopraffare sconvenientemente dalle risentite maniere e dalla collera poco rispettosa del figlio. Oltre a questo un altro difetto dobbiam notare, benchè conduca con un bellissimo colpo di scena allo sviluppo della favola, ed in questa censura andiamo d'accordo col sovra citato sig. Schedoni. Vogliam dire, che non è dicevole al buon costume, comechè possa riconoscersi verosimile e probabile, che la savia e modesta Adele, per dare l'ultimo addio al marchese, di cui si crede imminente la partenza, esca di notte delle sue camere (scena X atto 3.°), si arrechi presso alla strada con la troppo compassionevole cameriera, e quivi tenga un amoroso colloquio coll'amante; colloquio che viene improvvisamente interrotto dall'officiale Filippo nelle cui mani, per un accidente singolarissimo, era poc'anzi caduto un viglietto dell'innamorata sorella diretto a Fontanges.
[...]
(I) Trattenimento sopra le commedie del Nota. Modena 1826.
