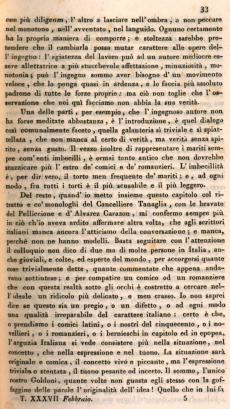
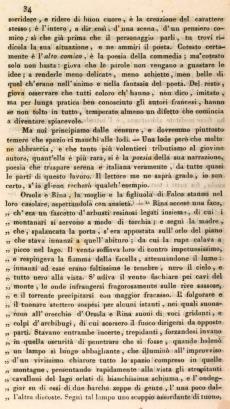
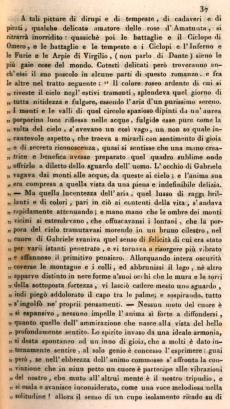
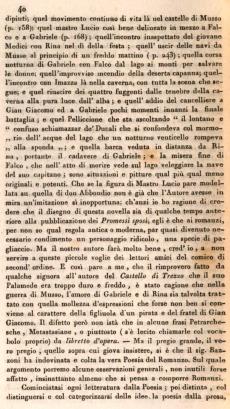
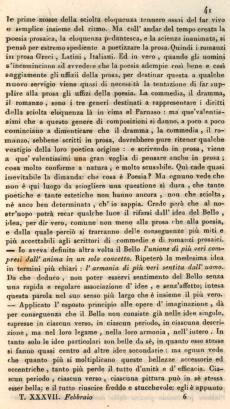
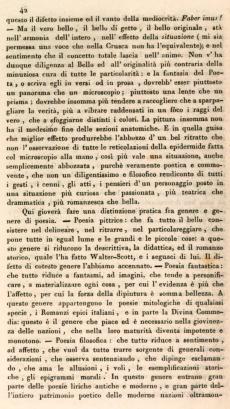
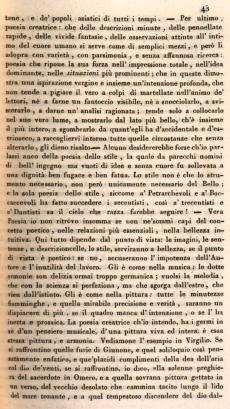
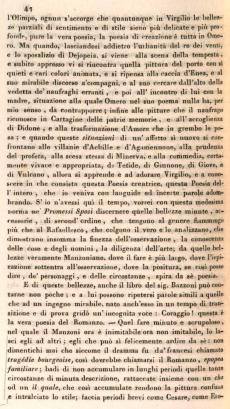
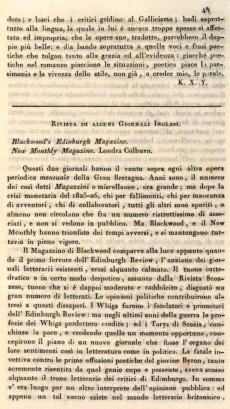
[...]
Una delle parti, per esempio, che l'ingegnoso autore non ha forse meditate abbastanza, è l'introduzione, è quel dialogo così comunalmente faceto, quella galanteria sì triviale e sì spiattellata, che non manca al certo di verità, ma verità senza spirito, senza gusto. Il vezzo inoltre di rappresentare i mariti sempre com' enti imbecilli, è ormai tanto antico che non dovrebbe stuzzicare più l'estro de' comici e de' romanzieri. L'imbecillità è, per dir vero, il torto men frequente de' mariti; e, ad ogni modo, fra tutti i torti è il più scusabile e il più leggero.
Del resto, quand'io metto insieme questo capitolo col ritratto e co' monologhi del Cancelliere Tanaglia, con le bravate del Pelliccione e d'Alvarez Carazon, mi confermo sempre più in ciò ch'io aveva ardito affermare altra volta, che agli scrittori italiani manca ancora l'atticismo della conversazione; e manca, perchè non ne hanno modelli. Basta seguitare con l'attenzione il colloquio non dico di due ma di molte persone in Italia, anche gioviali, e colte, ed esperte del mondo, per accorgersi quante cose trivialmente dette, quante commentate che appena andavano sottintese; e per compatire un comico od un romanziere che con questa realtà sotto gli occhi è costretto a cercare nell'ideale un ridicolo più delicato, e men crasso. lo non saprei dire se questo sia un pregio, o un difetto, o ad ogni modo una qualità irreparabile del carattere italiano: certo è che, o prendiamo i comici latini, o i nostri del cinquecento, o i novellieri, o i romanzieri, o i bernieschi in capitolo ed in epopea, l'arguzia Italiana si vede consistere più nella situazione, nel concetto, che nella espressione e nel tuono. La situazione sarà originale e comica, il concetto vivo e piccante, ma l'espressione triviale o stentata, il tuono pesante od incerto. Il sommo, l'unico nostro Goldoni, quante volte non guasta egli stesso con la goffaggine delle parole l'originalità dell'idea! Quello che in lui fa sorridere, e ridere di buon cuore, è la creazione del carattere stesso; è l'intero, a dir così, d'una scena, d'un pensiero comico; sì che già prima che il personaggio parli, tu trovi ridicola la sua situazione, e ne ammiri il poeta. Cotesto certamente è l'alto comico, è la poesia della commedia; ma cotesto solo non basta: giova che le parole non vengano a guastare le idee; a renderle meno delicate, meno schiette, men belle di quel ch'erano nell'animo e nella fantasia del poeta. Del resto, giova osservare che tutti coloro ch'hanno, non dico, imitato, ma per lunga pratica ben conosciuto gli autori francesi, hanno se non tolto in tutto, temperato almeno un difetto che comincia a diventare spiacevole.
Ma noi principiamo dalle censure, e dovremmo piuttosto temere che spazio ci manchi alle lodi. — Una lode però che molte ne abbraccia, e che tanto più volentieri tributiamo al giovine autore, quant'ella è più rara, si è la poesia della sua narrazione, poesia che traspare serena e italiana veramente, da tutte quasi le parti di questo lavoro. Il lettore me ne saprà grado, io son certo, s'io gliene recherò qualch'esempio.
[...]
A tali pitture di dirupi e di tempeste, di cadaveri e di pirati, qualche delicato amatore delle rose d'Amatunta, si ritrarrà inorridito: quasichè poi le battaglie e il Ciclope di Omero, e le battaglie e le tempeste e i Ciclopi e l'Inferno e le Furie e le Arpie di Virgilio, (non parlo di Dante) sieno le più gaie cose del mondo. [...]
Che se la figura di Mastro Lucio pare modellata su quella di don Abbondio non è già che l'Autore avesse in mira un'imitazione sì inopportuna; ch'anzi io ho ragione di credere che il disegno di questa novella sia di qualche tempo anteriore alla pubblicazione dei Promessi sposi; egli è che ai romanzi, per non so qual regola antica o moderna, par quasi divenuto necessario condimento un personaggio ridicolo, una specie di pagliaccio. Ma il nostro autore farà molto bene, cred'io, a non servire a queste piccole voglie dei lettori amici del comico di second'ordine. E così pare a me, che il rimprovero fatto da qualche signora all'autore del Castello di Trezzo che il suo Palamede era troppo duro e freddo, è stato cagione che nella guerra di Musso, l'amore di Gabriele e di Rina sia talvolta trattato con quella mollezza d'espressioni che forse non ben si conviene al carattere della figliuola d'un pirata e del fratel di Gian Giacomo. Il difetto però non istà che in alcune frasi Petrarchesche, Metastasiane, o piuttosto (s'è lecito chiamarle col vocabolo proprio) da libretto d'opera. — Ma il pregio grande, il vero pregio, quello sopra cui giova insistere, si è che il sig. Bazzoni ha indovinata e colta la vera Poesia del Romanzo. Sul quale argomento porremo alcune osservazioni generali, non inutili forse affatto, insinattanto almeno che si pensa a comporre Romanzi.
Cominciatasi ogni letteratura dalla Poesia; poi distinta, col distinguersi e col categorizzarsi delle idee, la poesia dalla prosa, le prime mosse della sciolta eloquenza tennero assai del far vivo e semplice insieme del ritmo. Ma coll'andar del tempo creata la poesia prosaica, la eloquenza pedantesca, e la scienza inanimata, si pensò per estremo spediente a poetizzare la prosa. Quindi i romanzi in prosa Greci, Latini, Italiani. Ed in vero, quando gli uomini s'incominciano ad avvedere che la poesia adempie così bene e così saggiamente gli uffizii della prosa, per destinar questa a qualche nuovo servigio viene quasi di necessità la tentazione di far supplire alla prosa gli uffizi della poesia. La commedia, il dramma, il romanzo, sono i tre generi destinati a rappresentare i diritti della sciolta eloquenza là in cima al Parnaso: ma que' valentissimi che a questo genere di composizioni si danno, a poco a poco cominciano a dimenticare che il dramma, la commedia, il romanzo, sebbene scritti in prosa, dovrebbero pure ritener qualche vestigio della loro poetica origine: e scrivendo in prosa, viene a que' valentissimi una gran voglia di pensare anche in prosa; cosa molto conforme a natura, e molto scusabile. Qui cade quasi inevitabile la dimanda: che cosa è Poesia? Ma ognuno vede che non è qui luogo da sciogliere una questione sì dura, che tante poetiche e tante estetiche non hanno ancora, non che sciolta, nè anco ben determinata, ch'io sappia. Credo però che al nostr'uopo potrà recar qualche luce il rifarsi dall'idea del Bello, idea, per dir vero, comune non meno alla prosa che alla poesia, e dalla quale perciò si trarranno delle conseguenze più miti e più accettabili agli scrittori di commedie e di romanzi prosaici. — Io aveva definito altra volta il Bello l'unione di più veri compresi dall'anima in un solo concetto. Ripeterò la medesima idea in termini più chiari: l'armonia di più veri sentita dall'uomo. Da che deduco, non poter esservi sentimento del Bello senza una rapida e regolare associazione d'idee, e senz'affetto; intesa questa parola nel suo senso più largo che è insieme il più vero. — Applicato l'esposto principio alle opere d'imaginazione, dà per conseguenza che il Bello non consiste già nelle idee singole, espresse in ciascun verso, in ciascun periodo, in ciascuna descrizione, ma nel loro legame, nella loro armonia, nell'intero. In tanto solo le idee particolari son belle da sè, in quanto esse stesse si fanno quasi centro ad altre idee secondarie: ma ognun vede che quanto più si moltiplicano queste bellezze accessorie ed eccentriche, tanto più perde il tutto d'unità e d'efficacia. Ciascun periodo, ciascun verso, ciascuna pittura può in sè stessa esser bella; e il tutto riuscire freddo e stucchevole: egli è appunto questo il difetto insieme ed il vanto della mediocrità. Faber imus! — Ma il vero bello, il bello di getto, il bello originale, stà nell'armonia dell'intero, nell'effetto della situazione (mi sia permessa una voce che nella Crusca non ha l'equivalente); e nel sentimento che il concetto totale lascia nell'animo. Non v'ha dunque diligenza al Bello ed all'originalità più contraria della minuziosa cura di tutte le particolarità: e la fantasia del Poeta, o scriva egli in versi od in prosa, dovrebbe esser piuttosto un panorama che un microscopio; piuttosto una lente che un prisma; dovrebbe insomma più tendere a raccogliere che a sparpagliare la verità, più a vibrare raddensati in un fôco i raggi del vero, che a sfoggiarne distinti i colori. La pittura insomma non ha il medesimo fine delle sezioni anatomiche. E in quella guisa che miglior effetto produrrebbe l'abbozzo d'un bel ritratto che non l'osservazione di tutte le reticolazioni della epidermide fatta col microscopio alla mano, così più vale una situazione, anche semplicemente abbozzata, purchè veramente poetica e commovente, che non un diligentissimo e filosofico rendiconto di tutti i gesti, i cenni, gli atti, i pensieri d'un personaggio posto in una situazione più curiosa che passionata, più teatrica che drammatica, più romanzesca che bella.
Qui gioverà fare una distinzione pratica fra genere e genere di poesia. — Poesia pittrice: che fa tutto il bello consistere nel delineare, nel ritrarre, nel particolareggiare, che pone tutte in egual lume e le grandi e le piccole cose: a questo genere si riducono la descrittiva, la didattica, ed il romanzo storico, quale l'ha fatto Walter-Scott, e i seguaci di lui. Il difetto di cotesto genere l'abbiamo accennato. — Poesia fantastica: che tutto riduce a fantasmi, ad imagini, che tende a personificare, a materializzare ogni cosa, per cui l'evidenza è più che l'affetto, per cui la forza della dipintura è somma bellezza. A questo genere appartengono le poesie mitologiche di qualsiasi specie, i Romanzi epici italiani, e in parte la Divina Commedia: questo è il genere che piace ed è necessario nella giovinezza delle nazioni, che nella loro maturità diventa impotente e monotono. — Poesia filosofica: che tutto riduce a sentimento, ad affetto, che vuol da tutto trarre sorgente di generali considerazioni, che osserva sentenziando, che dipinge esclamando, che ama le allusioni, i voli, le esemplificazioni storiche, gli epigrammi morali. In questo genere entrano gran parte delle poesie liriche antiche e moderne, e gran parte dell'intiero patrimonio poetico delle moderne nazioni oltramontane, e de' popoli asiatici di tutti i tempi. — Per ultimo poesia creatrice: che delle descrizioni minute, delle pennellate rapide, delle vivide fantasie, delle osservazioni attinte all'intimo del cuore umano si serve come di semplici mezzi, e però li adopra con varietà, con parsimonia, e senza affannosa ricerca: poesia che ripone la sua forza nell'impressione totale, nell'idea dominante, nelle situazioni più prominenti; che in queste dimostra una ispirazione vergine e insieme un'intenzione profonda, che non tende a pigiare il vero a colpi di martellate nell'animo de' lettori, nè a farne un fantoccio visibile, nè a snocciolarlo, a sviscerarlo, a darne un analisi ragionata; tende solo a collocarlo nel suo vero lume, a mostrarlo dal lato più bello, ch'è insieme il più intero, a sgombrarlo da quant'egli ha d'accidentale e d'estrinseco, a raccogliervi intorno tutte quelle circostanze che senza alterarlo, gli dieno risalto. — Alcuno desidererebbe forse ch'io parlassi anco della poesia dello stile, la quale da parecchi uomini di bell'ingegno ma vuoti di idee e senza cuore fu sollevata a una dignità ben fugace e ben fatua. Lo stile non è che lo strumento necessario, non però unicamente necessario del Bello; e la sola poesia dello stile, siccome a' Petrarchevoli e a' Boccaccevoli ha fatto succedere i secentisti, cosi a' trecentisti e a' Dantisti sa il cielo che razza farebbe seguire! — Vera Poesia io non ritrovo insomma se non ne' sommi capi del concetto poetico, nelle relazioni più essenziali, nella bellezza intuitiva. Qui tutto dipende dal punto di vista: le imagini, le sentenze, e descrizioncelle, lo stile, serviranno a bellezza, se il punto di vista è poetico: se no, accuseranno l'impotenza dell'Autore e l'inutilità del lavoro. Gli è come nella musica: le dotte armonie son delizia ormai troppo germanica; vuolsi la melodia, che con la scienza si perfeziona , ma che sgorga dall'estro, che vien dall'istinto. Gli è come nella pittura: tutte le minutezze fiamminghe, e quella mirabile precisione e verità, saranno un dispiacere di più, se il quadro manca d'intenzione, o se l'ha inetta e prosaica. La poesia creatrice ch'io intendo, ha i germi in sè d'un pensiero musicale, d'una pittura viva ed intera: è essa stessa pittura, e armonia. Vediamone l'esempio in Virgilio. Se si raffrontino quelle furie di Giunone, e quel soliloquio cosi pensatamente enfatico, e que' placidi complimenti della dea dell'aria col dio de' venti, se si raffrontino, io dico, alla solenne preghiera del sacerdote in Omero, e a quella sovrana pittura gettata in un verso, del vecchio desolato che cammina tacito lungo il lido del mare tonante, e a quel tempestoso discendere del dio dall'Olimpo, ognun s'accorge che quantunque in Virgilio le bellezze parziali di sentimento e di stile sieno più delicate e più profonde, pure la vera poesia, la poesia di creazione è tutta in Omero. Ma quando, lasciandosi addietro l'urbanità del re dei venti, e lo sposalizio di Dejopeia, si viene alla scena della tempesta, e subito appresso vi si rincontra quella pittura del porto con sì quieti e cari colori animata, e si ripensa alla caccia d'Enea, e al suo mirabile discorso a' compagni, e al suo cercare dall'alto della vedetta de' naufraghi erranti, e poi all'incontro di lui con la madre, situazione alla quale Omero nel suo poema nulla ha, per mio senso, da contrapporre; infine alle pitture che il naufrago riconosce in Cartagine delle patrie memorie, e all'accoglienza di Didone, e alla trasformazione d'Amore che in grembo le posa; e quando queste situazioni di un'affetto si nuovo si confrontano alle villanie d'Achille e d'Agamennone, alla prudenza del profeta, alla scesa stessa di Minerva, e alla commedia, certamente vivace e appropriata, di Tetide, di Giunone, di Giove, e di Vulcano, allora si apprende e ad adorare Virgilio, e a conoscere in che consista questa Poesia creatrice, questa Poesia dell'intero, che io veniva con languide ed incerte parole adombrando. S'io n'avessi qui il tempo, vorrei con questa medesima norma ne' Promessi Sposi discernere quelle bellezze minute, accessorie, di second'ordine, che tengono al genere fiammingo più che al Rafaellesco, che colgono il vero e lo analizzano, che dimostrano insomma la finezza dell'osservazione, la conoscenza delle cose e degli uomini, la diligenza dell'arte; da quelle bellezze veramente Manzoniane, dove il fare è più largo, dove l'ispirazione sottentra all'osservazione, dove la positura, se così posso dire, de' personaggi, e delle circostanze, spira da sè poesia.
E di queste bellezze, anche il libro del sig. Bazzoni può contarne non poche; e a lui possono ripetersi parole simili a quelle che ad un ingegno mirabile, nato anch'esso in un tempo di transizione e di prova gridò un'incognita voce: Coraggio! questa è la vera poesia del Romanzo. — Quel fare minuto e scrupoloso, nel quale il Manzoni ora è inimitabile ora non imitabile, lo lasci egli ad altri; egli che può si felicemente ardire da sè: non dimentichi mai che siccome il dramma fu da' francesi chiamato tragédie bourgeoise, così dovrebbe chiamarsi il Romanzo, epopea familiare; badi di non accumulare in lunghi periodi quelle tante circostanze di minuta descrizione, rattaccate insieme con un che od un il quale, che così accumulate rendono la pittura confusa e intralciato lo stile; faccia periodi brevi come Cesare, come Erodoto; e lasci che i critici gridino al Gallicismo; badi soprattutto alla lingua, la quale in lui è ancora troppo spesso si affettata ed impropria, che le opere sue, tradotte, parrebbero il doppio più belle; e dia bando sopratutto a quelle voci e frasi poetiche che tolgon tanto alla grazia ed all'evidenza: giacchè poetiche nel romanzo piacciono le situazioni, poetica piace parsimonia e la vivezza dello stile, non già, a creder mio, le parole.
K.X.Y.
