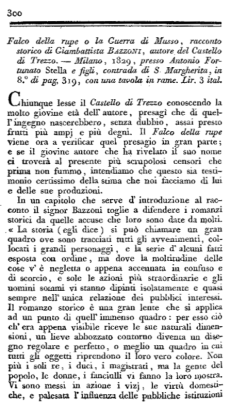
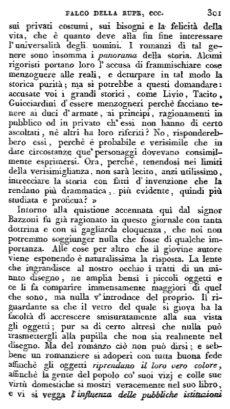

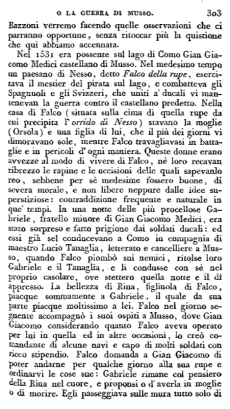
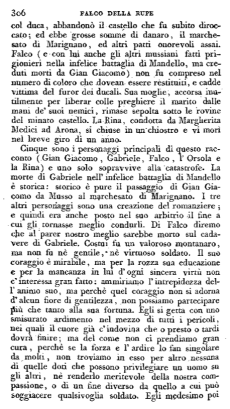
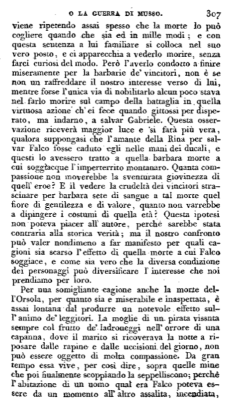
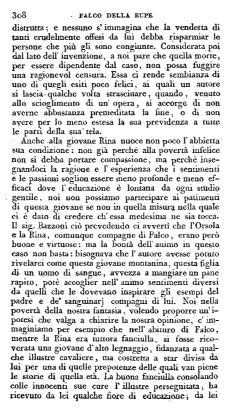
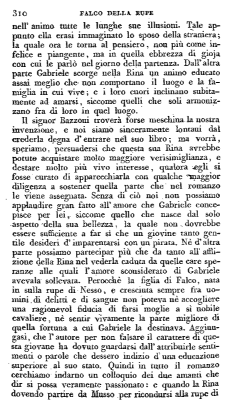
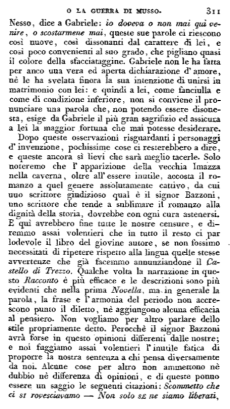
Falco della rupe o la Guerra di Musso, racconto storico di Giambattista BAZZONI, autore del Castello di Trezzo. — Milano, 1829, presso Antonio Fortunato Stella e figli, contrada di S. Margherita, in 8.° di pag. 319, con una tavola in rame. Lir. 3 ital.
Chiunque lesse il Castello di Trezzo conoscendo la molto giovine età dell'autore, presagì che di quell'ingegno nascerebbero, senza dubbio, assai presto frutti più ampj e più degni. Il Falco della rupe viene ora a verificar quel presagio in gran parte; e se il giovine autore che ha rivelato il suo nome ci troverà al presente più scrupolosi censori che prima non fummo, intendiamo che questo sia testimonio certissimo della stima che noi facciamo di lui e delle sue produzioni.
In un capitolo che serve d'introduzione al racconto il signor Bazzoni toglie a difendere i romanzi storici da quelle accuse che loro sono date da molti. "La storia (egli dice) si può chiamare un gran quadro ove sono tracciati tutti gli avvenimenti, collocati i grandi personaggi, e la serie d'alcuni fatti esposta con ordine, ma dove la moltitudine delle cose v'è negletta o appena accennata in confuso e di scorcio, e sole le azioni più straordinarie e gli uomini sommi vi stanno dipinti isolatamente e quasi sempre nell'unica relazione dei pubblici interessi. Il romanzo storico è una gran lente che si applica ad un punto di quell'immenso quadro: per esso ciò ch'era appena visibile riceve le sue naturali dimensioni, un lieve abbozzato contorno diventa un disegno regolare e perfetto, o meglio un quadro in cui tutti gli oggetti riprendono il loro vero colore. Non più i soli re, i duci, i magistrati, ma la gente del popolo, le donne, i fanciulli vi fanno la loro mostra. Vi sono messi in azione i vizj, le virtù domestiche, e palesata l'influenza delle pubbliche istituzioni sui privati costumi, sui bisogni e la felicità della vita, che è quanto deve alla fin fine interessare l'universalità degli uomini. I romanzi di tal genere sono insomma i panorama della storia. Alcuni rigoristi portano loro l'accusa di frammischiare cose menzognere alle reali, e deturpare in tal modo la storica purità; ma si potrebbe a questi domandare: accusate voi i grandi storici, come Livio, Tacito, Guicciardini d'essere menzogneri perchè facciano tenere ai duci d'armate, ai principi, ragionamenti in pubblico od in privato ch'essi non hanno di certo ascoltati, nè altri ha loro riferiti? No, risponderebbero essi, perchè è probabile e verisimile che in date circostanze que' personaggi dovevano consimilmente esprimersi. Ora, perchè, tenendosi nei limiti della verisimiglianza, non sarà lecito, anzi utilissimo, intrecciare la storia con fatti d'invenzione che la rendano più drammatica, più evidente, quindi più studiata e proficua?"
Intorno alla quistione accennata qui dal signor Bazzoni fu già ragionato in questo giornale con tanta dottrina e con sì gagliarda eloquenza, che noi non potremmo soggiunger nulla che fosse di qualche importanza. Alle cose per altro che il giovine autore viene esponendo è naturalissima la risposta. La lente che ingrandisce al nostro occhio i tratti di un minuto disegno, ne amplia bensì i piccoli oggetti e ce li fa comparire immensamente maggiori di quel che sono, ma nulla v'introduce del proprio. Il riguardante sa che il vetro del quale si giova ha la facoltà di accrescere smisuratamente alla sua vista gli oggetti; pur sa di certo altresì che nulla può trasmettergli alla pupilla che non sia realmente nel disegno. Ma del romanzo ciò non può dirsi; e sebbene un romanziere si adoperi con tutta buona fede affinchè gli oggetti riprendano il loro vero colore, affinchè la gente del popolo co' suoi vizj e colle sue virtù domestiche si mostri veracemente nel suo libro, e vi si vegga l'influenza delle pubbliche istituzioni sui privati costumi, nondimeno troppe cagioni possono concorrere a far sì che s'inganni egli stesso e tragga altrui in errore. Quanti poi per private passioni deducono false conseguenze dai fatti storici! L'utilità dunque di siffatti romanzi è ben lungi da l'essere nè tanta, nè così certa, come il nostro autore se la figura. In quanto poi a ragionamenti che molti autori attribuiscono a storici personaggi, sebbene sia certo che non parlarono mai di quel modo, il paragone ci sembra ancor più inopportuno. Quei ragionamenti lasciano intatta la storica verità: non tolgono, non aggiungono nulla agli avvenimenti, e quindi nè vogliono, nè possono trarci in inganno rispetto alla cognizione dei fatti, e non ponno per conseguenza somigliarsi alle invenzioni che un romanziere viene intrecciando alla storia. Nè quei discorsi ci piacciono massimamente per la verisimiglianza, come suppone il signor Bazzoni; ma sì piuttosto per la sapienza politica, qualora di questa abbia saputo arricchirli chi li compose. Il lettore del Machiavelli può saltarne a piè pari i discorsi, e ragionare col suo proprio giudizio sui fatti genuinamente narrati dall'autore; ma in un romanzo dove le invenzioni sono intrecciate alla storia, come possiamo distinguere il vero dal falso per giudicare se il carattere di un secolo o di un personaggio ci venne fedelmente rappresentato? Però il signor Bazzoni non dovrebbe chiamar rigoristi coloro i quali procacciano di trar d'errore chi stima di poter sostituire lo studio dei romanzi atorici a quello della storia propriamente detta. S'egli ha sortita una potente inclinazione a scriver romanzi storici, noi non tenteremo per certo di ritrarlo da questa via; ma non cesseremo dal dire che l'utilità di siffatte produzioni è piuttosto apparente che vera, e sopra tutto consiglieremo la gioventù desiderosa di buone e vere cognizioni a valersi della lente del proprio giudizio, anzi che di quella de' romanzieri per istudiare la storia. Esaminando poi il nuovo romanzo del signor Bazzoni verremo facendo quelle osservazioni che ci parranno opportune, senza ritoccar più la quistione che qui abbiamo accennata.
[...]
Cinque sono i personaggi principali di questo racconto (Gian Giacomo, Gabriele, Falco, l'Orsola e la Rina) e uno solo sopravvive alla catastrofe. La morte di Gabriele nell'infelice battaglia di Mandello è storica: storico è pure il passaggio di Gian Giacomo da Musso al marchesato di Marignano. I tre altri personaggi sono una creazione del romanziere; e quindi era anche posto nel suo arbitrio il fine a cui gli tornasse meglio condurli. Di Falco diremo che al parer nostro meglio sarebbe morto sul cadavere di Gabriele. Costui fu un valoroso montanaro, ma non fu nè gentile, nè virtuoso soldato. Il suo coraggio è mirabile, ma per la rozza sua educazione e per la mancanza in lui d'ogni sincera virtù non c'interessa gran fatto: ammiriamo l'intrepidezza dell'animo suo, ma perchè quel coraggio non si adorna d'alcun fiore di gentilezza, non possiamo partecipare più che tanto alla sua fortuna. Egli si getta con uno smisurato ardimento nel mezzo di tutti i pericoli, nei quali il cuore già c'indovina che o presto o tardi dovrà finire; ma del come non ci prendiamo gran cura, perchè se la forza e l'ardire lo fan singolare da molti, non troviamo in esso per altro nessuna di quelle doti che possono privilegiare un uomo su gli altri, nè renderlo meritevole della nostra compassione, o di un fine diverso da quello a cui può soggiacere qualsivoglia soldato. Egli medesimo poi viene ripetendo assai spesso che la morte lo può cogliere quando che sia ed in mille modi; e con questa sentenza a lui familiare si colloca nel suo vero posto, e ci apparecchia a vederlo morire, senza farci curiosi del modo. Però l'averlo condotto a finire miseramente per la barbarie de' vincitori, non è se non un raffreddare il nostro interesse verso di lui, mentre forse l'unica via di nobilitarlo alcun poco stava nel farlo morire sul campo della battaglia in quella virtuosa azione ch'ei fece quando gittossi per disperato, ma indarno, a salvar Gabriele. Questa osservazione riceverà maggior luce e si farà più vera, qualora suppongasi che l'amante della Rina per salvar Falco fosse caduto egli nelle mani dei ducali, e questi lo avessero tratto a quella barbara morte a cui soggiacque l'imperterrito montanaro. Quanta compassione non moverebbe la sventurata giovinezza di quell'eroe? E il vedere la crudeltà dei vincitori strascinare per barbara sete di sangue a tal morte quel fiore di gentilezza e di valore, quanto non varrebbe a dipingere i costumi di quella età? Questa ipotesi non poteva piacer all'autore, perche sarebbe stata contraria alla storica verità; ma il nostro confronto può valer nondimeno a far manifesto per quali cagioni sia scarso l'effetto di quella morte a cui Falco soggiace, e come sia vero che la diversa condizione dei personaggi può diversificare l'interesse che noi prendiamo per loro.
Per una somigliante cagione anche la morte dell'Orsola, per quanto sia e miserabile e inaspettata, è assai lontana dal produrre un notevole effetto sull'animo de' leggitori. La moglie di un pirata vissuta sempre col frutto de' ladroneggi nell'orrore di una capanna, dove il marito si ricoverava la notte a riposare dalle rapine e dalle uccisioni del giorno, non può essere oggetto di molta compassione. Da gran tempo essa vive, per così dire, sopra quelle mine che poi finalmente scoppiando la seppelliscono; perchè l'abitazione di un uomo qual era Falco poteva essere da un momento all'altro assalita, incendiata, distrutta; e nessuno s'immagina che la vendetta di tanti crudelmente offesi da lui debba risparmiar le persone che più gli sono congiunte. Considerata poi dal lato dell'invenzione, a noi pare che quella morte, per essere dipendente dal caso, non possa fuggire una ragionevol censura. Essa ci rende sembianza di uno di quegli esiti poco felici, ai quali un autore si lascia qualche volta strascinare, quando, venuto allo scioglimento di un'opera, si accorge di non averne abbastanza premeditata la fine, o di non avere per lo meno estesa la sua previdenza a tutte le parti della sua tela.
Anche alla giovane Rina nuoce non poco l'abbietta sua condizione: non già perchè alla povertà infelice non si debba portare compassione, ma perchè insegnandoci la ragione e l'esperienza che i sentimenti e le passioni soglion essere meno profonde e meno efficaci dove l'educazione è lontana da ogni studio gentile, noi non possiamo partecipare ai patimenti di questa giovane se non in quella misura nella quale ci è dato di credere ch'essa medesima ne sia tocca. Il sig. Bazzoni ciò prevedendo ci avvertì che l'Orsola e la Rina, comunque compagne di Falco, erano però buone e virtuose: ma la bontà dell'animo in questo caso non basta: bisognava che l'autore avesse potuto rivelarci come questa giovane montanina, questa figlia di un uomo di sangue, avvezza a mangiare un pane rapito, potè accoglier nell'animo sentimenti diversi da quelli che le dovevano inspirare gli esempi del padre e de' sanguinarj compagni di lui. [...]
Il signor Bazzoni troverà forse meschina la nostra invenzione, e noi siamo sinceramente lontani dal crederla degna d'entrare nel suo libro; ma vorrà, speriamo, persuadersi che questa sua Rina avrebbe potuto acquistare molto maggiore verisimiglianza, e destare molto più vivo interesse, qualora egli si fosse curato di apparecchiarla con qualche maggior diligenza a sostener quella parte che nel romanzo le viene assegnata. Senza di ciò noi non possiamo applaudire gran fatto all'amore che Gabriele concepisce per lei, siccome quello che nasce dal solo aspetto della sua bellezza, la quale non dovrebbe essere sufficiente a far sì che un giovine tanto gentile desideri d'imparentarsi con un pirata. Nè d'altra parte possiamo partecipar più che da tanto all'afflizione della Rina nel vederla caduta da quelle care speranze alle quali l'amore sconsiderato di Gabriele avevala sollevata. Perocchè la figlia di Falco, nata in sulla rupe di Nesso, e cresciuta sempre fra uomini di delitti e di sangue non poteva nè accogliere una ragionevol fiducia di farsi moglie a sì nobile cavaliere, nè sentir vivamente la parte migliore di quella fortuna a cui Gabriele la destinava. Aggiungasi, che l'autore per non falsare il carattere di questa giovane ha dovuto guardarsi dall'attribuirle sentimenti o parole che dessero indizio d'una educazione superiore al suo stato. Quindi in tutto il romanzo cerchiamo indarno un colloquio dei due amanti che dir si possa veramente passionato: e quando la Rina dovendo partire da Musso per ricondursi alla rupe di Nesso, dice a Gabriele: io doveva o non mai qui venire, o scostarmene mai, queste sue parole ci riescono così nuove, così dissonanti dal carattere di lei, e così poco convenienti al suo grado, che pigliano quasi il colore della sfacciataggine. Gabriele non le ha fatta per anco una vera ed aperta dichiarazione d'amore, nè le ha svelata sinora la sua intenzione di unirsi in matrimonio con lei: e quindi a lei, come fanciulla e come di condizione inferiore, non si conviene il pronunciare una parola che, non potendo essere disonesta, esige da Gabriele il più gran sagrifizio ed assicura a lei la maggior fortuna che mai potesse desiderare.
[...]
