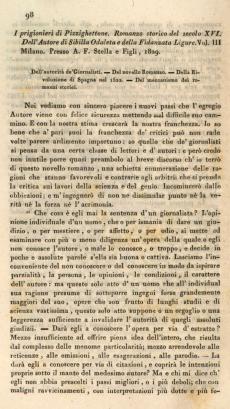
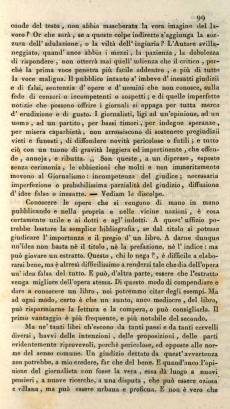
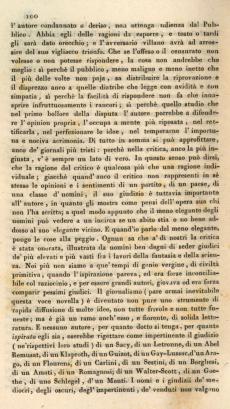
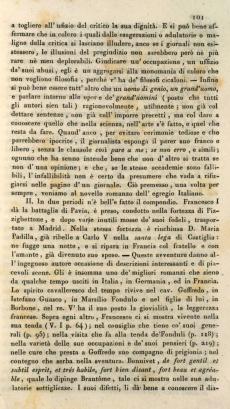
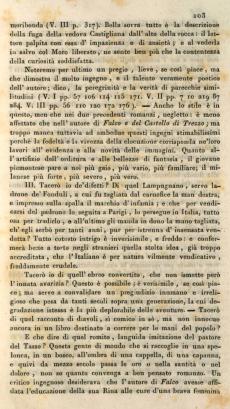
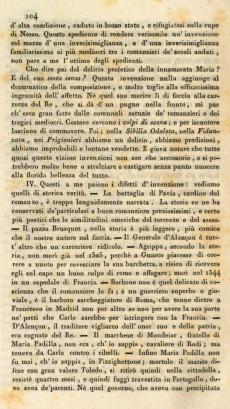
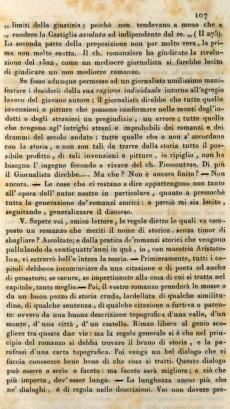
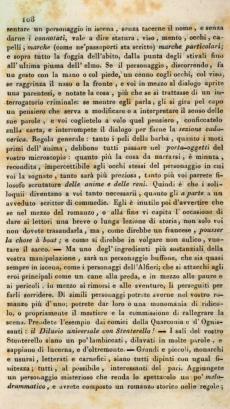
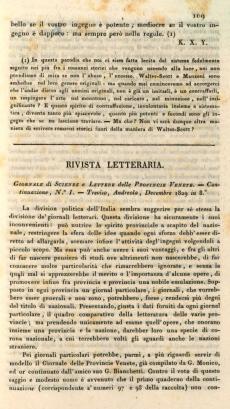
I prigionieri di Pizzighettone. Romanzo storico del secolo XVI. Dell'Autore di Sibilla Odaleta e della Fidanzata Ligure. Vol. III Milano. Presso A. F. Stella e Figli, 1829.
Dell'autorità de' Giornalisti. — Del novello Romanzo. — Della Rivoluzione di Spagna nel 1522. — Del meccanismo dei romanzi storici.
Noi vediamo con sincero piacere i nuovi passi che l'egregio Autore viene con felice sicurezza mettendo nel difficile suo cammino. E con la nostra stima crescerà la nostra franchezza. lo so bene che a' pari suoi la franchezza de' critici può non rade volte parere ardimento importuno: so quello che de' giornalisti si pensa da una certa classe di lettori e d'autori: e però credo non inutile porre quasi preambolo al breve discorso ch'io terrò di questo novello romanzo, una schietta enumerazione delle ragioni che stanno favorevoli e contrarie agli arbitrii che si prende la critica sui lavori della scienza e del genio. Incomincerò dalle obbiezioni; e m'ingegnerò di non ne dissimular punto nè la verità nè la forza nè l'acrimonia.
"Che cosa è egli mai la sentenza d'un giornalista? L'opinione individuale d'un uomo, che o per ismania di dare un giudizio, o per mestiere, o per affetto, o per odio, si mette ad esaminare con più o meno diligenza un'opera della quale o egli non conosce l'autore, o male lo conosce, o troppo, e decide in poche e assolute parole s'ella sia buona o cattiva. Lasciamo l'inconveniente del non conoscere o del conoscere in modo da ispirare parzialità, la persona, le opinioni, le condizioni, il carattere dell'autore: ma questo solo atto d'un uomo che all'individual sua ragione presume di sottoporre ingegni forse grandemente maggiori del suo, opere che son frutto di lunghi studii e di scienza vastissima, questo solo atto suppone o un orgoglio o una leggerezza sufficiente a invalidare l'autorità di quegli assoluti giudizii. — Darà egli a conoscere l'opera per via d'estratto? Mezzo insufficiente ad offrire piena idea dell'intero, che risulta dal complesso delle menome particolarità; mezzo arrendevole alle reticenze, alle omissioni, alle esagerazioni, alle parodie. — La darà egli a conoscere per via di citazioni, e coprirà le intenzioni proprie sotto il manto del medesimo autore? Ma e chi mi dice ch'egli non abbia prescelti i passi migliori, o i più deboli; che con maligni ravvicinamenti, con interpretazioni più dotte e più feconde del testo, non abbia mascherata la vera imagine del lavoro? Or che sarà, se a queste colpe indirette s'aggiunga la sozzura dell'adulazione, o la viltà dell'ingiuria? L'Autore svillaneggiato, quand'anco abbia i mezzi, la pazienza, la debolezza di rispondere, non otterrà mai quell'udienza che il critico, perchè la prima voce penetra più facile addentro, e più di tutte la voce maligna. Il pubblico intanto s'imbeve d'inesatti giudizio e di falsi, sentenzia d'opere e d'uomini che non conosce, sulla fede di censori o incompetenti o sospetti; e di quelle imperfette notizie che possono offrire i giornali si appaga per tutta merce d'erudizione e di gusto. I giornalisti, ligi ad un'opinione, ad un uomo, ad un partito, per bassi timori, per indegne speranze, per misera caparbietà, non arrossiscono di sostenere pregiudizio vieti e funesti, di diffondere novità pericolose o futili; e tutto ciò con un tuono di gravità leggiera ed impertinente, che offende, annoja, e ributta." Son queste, a un dipresso, esposte senza cerimonia, le obbiezioni che molti e non immeritamente movono al Giornalismo: incompetenza del giudice; necessaria imperfezione o probabilissima parzialità del giudizio, diffusione d'idee false o inesatte. — Vediam le discolpe.
Conoscere le opere che si vengono di mano in mano pubblicando e nella propria e nelle vicine nazioni, è cosa certamente utile e ai dotti e agl'indotti. A quest' uffizio potrebbe bastare la semplice bibliografia, se dal titolo si potesse giudicare l'importanza e il pregio d'un libro. A darne dunque un'idea non basta nè il titolo, nè la prefazione, nè l'indice: ma può giovare un estratto. Questo, chi lo nega?, è difficile a elaborarsi bene, ma è altresì difficilissimo a rendersi tale che dia dell'opera un'idea falsa del tutto. E può, d'altra parte, essere che l'estratto venga migliore dell'opera stessa. Di questo modo di compendiare e dare a conoscere un libro, noi potremmo citar degli esempi. Ma ad ogni modo, certo è che un sunto, anco mediocre, del libro, può risparmiarne la lettura e la compera, o può consigliarla. Il primo vantaggio è più frequente, e più notabile del secondo.
Ma ne' tanti libri ch'escono da tanti paesi e da tanti cervelli diversi, havvi delle intenzioni, delle proposizioni, delle parti evidentemente riprovevoli, perchè pericolose, ed opposte alle norme del senso comune. Un giudizio dettato da quest'avvertenza non potrebbe, a mio credere, far che del bene. E quand'anco l'opinione del giornalista non fosse la vera, essa dà luogo a nuovi pensieri, a nuove ricerche, a una disputa, che può essere oziosa e villana, ma può essere urbana e proficua. E non è vero che l'autore condannato o deriso, non ottenga udienza dal Pubblico. Abbia egli delle ragioni da esporre, e tosto o tardi gli sarà dato orecchio; e l'avversario villano avrà ad arrossire del suo vigliacco trionfo. Che se l'offeso o il censurato non volesse o non potesse rispondere, la cosa non andrebbe che meglio: sì perchè il pubblico, meno maligno e meno inetto che il più delle volte non paja, sa distribuire la riprovazione e il disprezzo anco a quelle diatribe che legge con avidità e con simpatia, sì perchè la facilità di rispondere non fa che innasprire infruttuosamente i rancori; sì perchè quello studio che nel primo bollore della disputa l'autore porrebbe a difendere l'opinion propria, l'occupa a mente più riposata, nel rettificarla, nel perfezionare le idee, nel temperarne l'importuna e nociva acrimonia. Di tutto in somma si può approfittare, anco de' giornali più tristi: perchè nella critica, anco la più ingiusta, v'è sempre un lato di vero. In questo senso può dirsi, che la ragione del critico è qualcosa più che una ragione individuale; giacchè quand'anco il critico non rappresenti in sè stesso le opinioni e i sentimenti di un partito, di un paese, di una classe d'uomini, il suo giudizio è tuttavia importante all' autore, in quanto gli mostra come pensi dell'opera sua chi non l'ha scritta; a quel modo appunto che il meno elegante degli uomini può vedere a un incirca se un abito stia o no bene addosso al suo elegante vicino. E quand'io parlo del meno elegante, pongo le cose alla peggio. Ognun sa che a' di nostri la critica è stata onorata, illustrata da uomini ben degni di seder giudici de' più elevati e più vasti fra i lavori della fantasia e della scienza. Noi più non siamo a que' tempi di genio vergine, di civiltà primitiva, quando l'ispirazione pareva, ed era forse inconciliabile col raziocinio, e per essere grandi autori, giovava od era forza comparir pessimi giudici. Il giornalismo (pare ormai inevitabile questa voce novella) è diventato non pure uno strumento di rapida diffusione di molte idee, non tutte frivole e non tutte funeste; ma è già un ramo anch'esso, e fiorente, di solida letteratura. E nessuno autore, per quanto dotto si tenga, per quanto ispirato egli sia, oserebbe rigettare come impertinente il giudizio (ne' rispettivi loro studi) di un Sacy, di un Letronne, di un Abel Remusat, di un Klaproth, di un Guizot, di un Gay-Lussac, d'un Arago, di un Flourens, di un Carlini, di un Sestini, di un Borghesi, di un Amati, di un Romagnosi; di un Walter-Scott, di un Goethe, di uno Schlegel, d'un Monti. I nomi e i giudizii de' mediocri, degli oscuri, degl'impertinenti, de' venduti non valgono a togliere all'ufizio del critico la sua dignità. E si può bene affermare che in coloro i quali dalle esagerazioni o adulatorie o maligne della critica si lasciano illudere, anco se i giornali non esistessero, le illusioni del pregiudizio non sarebbero però nè più rare nè men deplorabili. Giudicare un'occupazione, un ufizio da' suoi abusi, egli è un aggregarsi alla monomania di coloro che non vogliono filosofia, perchè v'ha de' filosofi cicaloni. — Infine si può bene essere tutt'altro che un uomo di genio, un grand'uomo, e parlare intorno alle opere de' grand'uomini (posto che tutti gli autori sien tali) ragionevolmente, utilmente; non già col dettare sentenze, non già coll'imporre precetti, ma col dare a conoscere quello che nella scienza, nell'arte s'è fatto, e quel che resta da fare. Quand'anco, per evitare cerimonie tediose e che parrebbero ipocrite, il giornalista esponga il parer suo franco e libero; senza le clausole così pare a me; se non erro, e simili; ognuno che ha senno intende bene che non d'altro si tratta se non d'una opinione; e che, se le stesse accademie sono fallibili, l'infallibilità non è certo da presumere che vada a rifugiarsi nelle pagine d'un giornale. Ciò premesso, una volta per sempre, veniamo al novello romanzo dell'egregio Italiano.
[...]
III. Tacerò io de' difetti? Di quel Lampugnano, servo ladrone de' Fonduli, a cui fu tagliata dal carnefice la man destra, e impresso sulla spalla il marchio d'infamia; e che per vendicarsi del padrone lo seguita a Parigi, lo persegue in Italia, tutto osa per tradirlo, o all'ultimo gli manda in dono la mano tagliata, ch'egli serbò per tanti anni, pur per istrenna d' insensata vendetta? Tutto cotesto intrigo è inverisimile, e freddo: e confermerà bene a torto negli stranieri quella stolta idea, già troppo accreditata, che l'Italiano è per natura vilmente vendicativo, freddamente crudele.
Tacerò io di quell'ebreo convertito, che non ismette però l'innata avarizia? Questo è possibile; è verisimile, se così piace; ma serve a convalidare un pregiudizio inumano e irreligioso che pesa da tanti secoli sopra una generazione, la cui degradazione istessa è la più deplorabile delle sventure. — Tacerò di quel racconto di diavoli, sì comico in sè, ma non innocuo ancora in un libro destinato a correre per le mani del popolo?
E che dire di quel romito, languida imitazione del pastore del Tasso? Questa gente di mondo che si raccoglie in una spelonca, in un bosco, all'ombra di una cappella, di una capanna, e quivi da mezzo secolo passa le ore o nella santità o nel dolore, non so quanto convenga a ben pensato romanzo. Un critico ingegnoso desiderava che l'autore di Falco avesse affidata l'educazione della sua Rina alle cure d'una brava femmina d'alta condizione, caduta in basso stato, e rifugiatasi sulla rupe di Nesso. Questo spediente di rendere verisimile un'invenzione col mezzo d'una inverisimiglianza, e d'una inverisimiglianza familiarissima ai più mediocri tra i romanzieri de' secoli andati, non pare a me l'ottimo degli spedienti.
Che dire poi del delirio profetico della innamorata Maria? E del suo sesto senso? Questa invenzione nulla aggiunge al drammatico della composizione, e molto toglie alla efficacissima ingenuità dell'affetto. Nè quel suo morire lì di faccia alla carrozza del Re, che si dà d'un pugno nella fronte, mi par ch'esca gran fatto dalle comunali astuzie de' romanzieri e dei tragici mediocri. Costoro cercano i colpi di scena; e per iscuotere lasciano di commovere. Poi; nella Sibilla Odaleta, nella Fidanzata, nei Prigionieri abbiamo un delirio, abbiamo predizioni, abbiamo improbabili e lontane vendette. E giova notare che tutte quasi queste viziose invenzioni non son che accessorie, e si potrebbero molto bene o stralciare o castigare senza punto nuocere alla florida bellezza del tutto.
[...]
Di più il Giornalista direbbe..... Ma che? Non è ancora finito? — Non ancora. — Le cose che ci restano a dire appartengono non tanto all'opera dell'autor nostro in particolare, quanto a pressochè tutta la generazione de' romanzi storici: e perciò mi sia lecito, seguitando, generalizzare il discorso.
V. Sapete voi, amico lettore, le regole dietro le quali va composto un romanzo che meriti il nome di storico, senza timor di sbagliare? Ascoltate; e dalla pratica de' romanzi storici che vengono pullulando da ventiquattr'anni in quà, io, con maestria Aristotelica, vi estrarrò bell'e intera la teoria. — Primieramente, tutti i capitoli debbono incominciare da una citazione o di poeta od anche di prosatore; se oscura, se impertinente alla cosa di cui si tratta nel capitolo, tanto meglio. — Poi, il vostro romanzo prenderà le mosse o da un buon pezzo di storia cruda, lardellata di qualche similitudine, di qualche sentenza, di qualche citazione o furtiva o patente: ovvero da una buona descrizione topografica d'una valle, d'un monte, d'una città , d'un castello. Riman libero al genio scegliere tra queste due vie: ma la regola generale si è che nel principio del romanzo si debba trovare il brano di storia, e la parafrasi d'una carta topografica. Poi venga un bel dialogo che vi faccia conoscere bene bene di che cosa si tratti. Questo dialogo può essere o serio o faceto: ma faceto sarà migliore; e ciò che più importa, dev'esser lungo. — La lunghezza ancor più che ne' dialoghi, è di regola nelle descrizioni. Voi non dovete presentare un personaggio in iscena, senza tacerne il nome, e senza darne i connotati, vale a dire statura, viso, mento, occhi, capelli, marche (come ne' passaporti sta scritto) marche particolari; e sopra tutto la foggia dell'abito, dalla punta degli stivali fino all'ultima piuma dell'elmo. Se il personaggio, discorrendo, fa un gesto con la mano o col piede, un cenno cogli occhi, col viso, se raggrinza il naso o la fronte, e voi in mezzo al dialogo aprite una parentesi, e notate la cosa, più che se si trattasse di un interrogatorio criminale: se mentre egli parla, gli si gira pel capo un pensiero che serva a modificare o a interpretare il senso delle sue parole, e voi coglietelo a volo quel pensiero, conficcatelo sulla carta, e interrompete il dialogo per farne la sezione cadaverica. Regola generale: tanto i peli della barba, quanto i moti primi dell'anima, debbono tutti passare nel porta-oggetti del vostro microscopio: quanto più la cosa da narrarsi, è minuta, recondita, impercettibile agli occhi stessi del personaggio in cui voi la sognate, tanto sarà più preziosa, tanto più voi parrete filosofo scrutatore delle anime e delle reni. Quindi è che i soliloquii diventano a voi tanto necessarii, quanto gli a parte a un avveduto scrittor di commedie. Egli è inutile poi d'avvertire che se nel mezzo del romanzo, o alla fine vi capita l'occasione di dare ai lettori una breve o lunga lezione di storia, non solo voi non dovete trasandarla, ma, come direbbe un francese, pousser la chose à bout; e come si direbbe in volgare non aulico, vuotare il sacco. — Ma uno degl'ingredienti più sostanziali della vostra manipolazione, sarà un personaggio buffone, che sia quasi sempre in iscena, come i personaggi dell'Alfieri; che si attacchi agli eroi principali come un cane alla preda, e in mezzo alle paure e ai pericoli, in mezzo ai rimorsi e alle sventure, li perseguiti per farli sorridere. Di simili personaggi potrete averne nel vostro romanzo più d'uno; potrete dar loro o una monomania di ridicolo, o propriamente il mestiere e la commissione di rallegrare la scena. Prendete l'esempio dai comici della Quarconia e d'Ognissanti: il Diluvio universale con Stenterello! — I sali del vostro Stenterello siano un po' lambiccati, dilavati in molte parole, e sappiano di lucerna, e d'oltremonte. — Grandi e piccoli, monarchi e usurai, letterati e carnefici, siano tutti dipinti con ugual finitezza; tutti, al possibile, interessanti del pari. Aggiungete un personaggio misterioso che renda lo spettacolo un po' melodrammatico, e avrete composto un romanzo storico nelle regole; bello se il vostro ingegno è potente; mediocre se il vostro ingegno è dappoco : ma sempre però nelle regole. (I)
K. X. Y.
(I) In questa parodia che noi ci siam fatta lecita del sistema fedelmente seguito nei più fra i romanzi storici che vengono uscendo alla luce, noi non prendiamo di mira se non l'abuso, l'eccesso. Walter-Scott e Manzoni sono ambedue nel loro genere originali: ma quando mai cominceremo ad accorgerci che l'andar dietro agli uomini originali, non è già un imitarli, è un contraffarli, un respingere l'arte nel monotono, nel caricato, nel minuzioso, nell'insignificante? E questo spirito di contraffazione, involontaria insieme e sistematica, diventa tanto più spiacevole, quanto più potenti e fecondi sono gli ingegni che se ne lasciano traviare. — Ma che? Non vi sarà dunque altra maniera di scrivere romanzi storici fuori della maniera di Walter-Scott?
