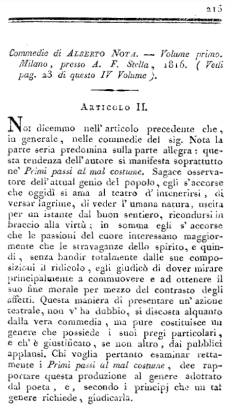
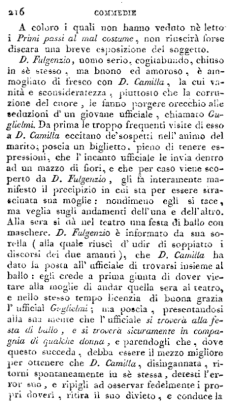
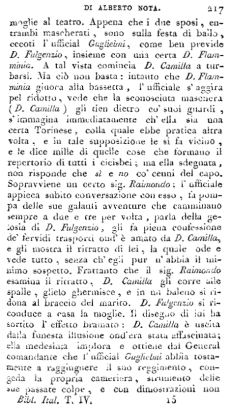
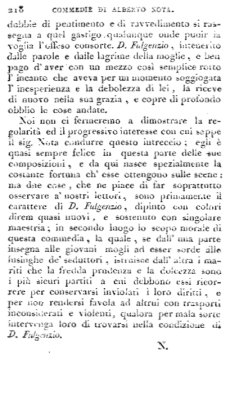
Commedie di ALBERTO NOTA. – Volume primo. Milano, presso A. F. Stella, 1816. (Vedi pag. 23 di questo IV Volume).
ARTICOLO II.
Noi dicemmo nell'articolo precedente che, in generale, nelle commedie del sig. Nota la parte seria predomina sulla parte allegra: questa tendenza dell'autore si manifesta soprattutto ne' Primi passi al mal costume. Sagace osservatore dell'attual genio del popolo, egli s'accorse che oggidì si ama al teatro d'intenerirsi, di versar lagrime, di veder l'umana natura, uscita per un istante dal buon sentiero, ricondursi in braccio alla virtù; in somma egli s'accorse che le passioni del cuore interessano maggiormente che le stravaganze dello spirito, e quindi, senza bandir totalmente dalle sue composizioni il ridicolo, egli giudicò di dover mirare principalmente a commuovere e ad ottenere il suo fine morale per mezzo del contrasto degli affetti. Questa maniera di presentare un'azione teatrale, non v'ha dubbio, si discosta alquanto dalla vera commedia, ma pure costituisce un genere che possiede i suoi pregi particolari, e ch'è giustificato, se non altro, dai pubblici applausi. Chi voglia pertanto esaminar rettamente i Primi passi al mal costume, dee rapportare questa produzione al genere adottato dal poeta, e, secondo i principj che un tal genere richiede, giudicarla.
A coloro i quali non hanno veduto nè letto i Primi passi al mal costume, non riuscirà forse discara una breve esposizione del soggetto.
D. Fulgenzio, uomo serio, cogitabundo, chiuso in sè stesso, ma buono ed amoroso, è ammogliato di fresco con D. Camilla, la cui vanità e sconsideratezza, piuttosto che la corruzione del cuore, le fanno porgere orecchio alle seduzioni d'un giovane ufficiale, chiamato Guglielmi. Da prima le troppo frequenti visite di esso a D. Camilla eccitano de' sospetti nell'animo del marito; poscia un biglietto, pieno di tenere espressioni, che l'incauto ufficiale le invia dentro ad un mazzo di fiori, e che per caso viene scoperto da D. Fulgenzio, gli fa interamente manifesto il precipizio in cui sta per essere strascinata sua moglie: nondimeno egli si tace, ma veglia sugli andamenti dell'una e dell'altro. Alla sera si dà nel teatro una festa di ballo con maschere. D. Fulgenzio è informato da sua sorella (alla quale riuscì d'udir di soppiatto i discorsi dei due amanti), che D. Camilla ha dato la posta all'ufficiale di trovarsi insieme al ballo: egli crede a prima giunta di dover vietare alla moglie di andar quella sera al teatro, e nello stesso tempo licenzia di buona grazia l'ufficial Guglielmi; ma poscia, presentandosi alla sua mente che l'ufficiale si troverà alla festa di ballo, e si troverà sicuramente in compagnia di qualche donna, e parendogli che, dove questo succeda, debba essere il mezzo migliore per ottenere che D. Camilla, disingannata, ritorni spontaneamente in sè stessa, detesti l'error suo, e ripigli ad osservar fedelmente i propri doveri, ritira il suo divieto, e conduce la moglie al teatro. Appena che i due sposi, entrambi mascherati, sono sulla festa di ballo eccoti l'ufficial Guglielmi, come ben previde D. Fulgenzio, insieme con una certa D. Flamminia. A tal vista comincia D. Camilla a turbarsi. Ma ciò non basta: intanto che D. Flamminia giuoca alla bassetta, l'ufficiale s'aggira pel ridotto, vede che la sconosciuta maschera (D. Camilla) gli tien dietro co' suoi guardi, s'immagina immediatamente ch'ella sia una certa Torinese, colla quale ebbe pratica altra volta, e in tale supposizione le si fa vicino e le dice mille di quelle cose che formano il repertorio di tutti i cicisbei; ma ella sdegnata, non risponde che sì e no co' cenni del capo. Sopravviene un certo sig. Raimondo: l'ufficiale appicca subito conversazione con esso, fa pompa delle sue galanti avventure che camminano sempre a due e tre per volta, parla della gelosia di D. Fulgenzio, gli fa piena confessione de' fervidi trasporti ond'è amato da D. Camilla, e gli mostra il ritratto di lei, la quale ode e vede tutto, senza ch'egli pur n'abbia il minimo sospetto. Frattanto che il sig. Raimondo esamina il ritratto, D. Camilla gli corre alle spalle, glielo ghermisce, e in un baleno si ridona al braccio del marito. D. Fulgenzio si riconduce a casa la moglie. Il disegno di lui ha sortito l'effetto bramato: D. Camilla è uscita dalla funesta illusione ond'era stata affascinata; ella medesima implora e ottiene dal General comandante che l'ufficial Guglielmi abbia tostamente a raggiugnere il suo reggimento, congeda la propria cameriera, strumento delle sue passate colpe, e con dimostrazioni non dubbie di pentimento e di ravvedimento si rassegna a quel gastigo qualunque onde punir la voglia l'offeso consorte. D. Fulgenzio, intenerito dalle parole e dalle lagrime della moglie, e ben pago d'aver con un mezzo così semplice rotto l'incanto che aveva per un momento soggiogata l'inesperienza e la debolezza di lei, la riceve di nuovo nella sua grazia, e copre di profondo obblio le cose andate.
Noi non ci fermeremo a dimostrare la regolarità ed il progressivo interesse con cui seppe il sig. Nota condurre questo intreccio; egli è quasi sempre felice in questa parte delle sue composizioni, e da qui nasce spezialmente la costante fortuna ch'esse ottengono sulle scene: ma due cose, che ne piace di far soprattutto osservare a' nostri lettori, sono primamente il carattere di D. Fulgenzio, dipinto con colori direm quasi nuovi, e sostenuto con singolare maestria; in secondo luogo lo scopo morale di questa commedia, la quale, se dall'una parte insegna alle giovani mogli ad esser sorde alle lusinghe de' seduttori, istruisce dall'altra i mariti che la fredda prudenza e la dolcezza sono i più sicuri partiti a cui debbono essi ricorrere per conservarsi inviolati i loro diritti, e per non rendersi favola ad altrui con trasporti inconsiderati e violenti, qualora per mala sorte intervenga loro di trovarsi nella condizione di D. Fulgenzio.
N.
