
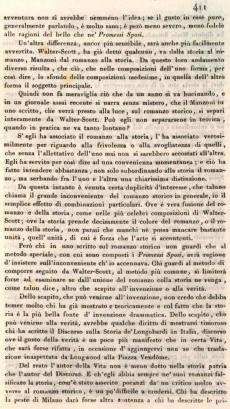
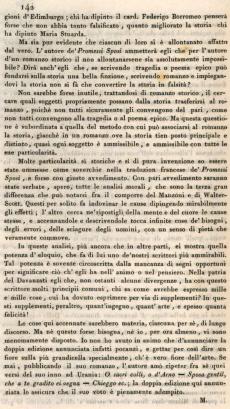
I Promessi Sposi d’ALESSANDRO MANZONI. Firenze, Passigli, Borghi e C. 1830, un volume in 8.° piccolo e sei in 32.° con vignette.
Un'edizione elegante (e la doppia, che qui si annuncia de' Promessi Sposi, massime quella in un sol volume, è veramente elegantissima) non prova per sè stessa la bellezza d’un’opera più che una veste elegante non provi la bellezza d’una persona. Pur quando viene dopo molt’altre; quand’è (come nel caso nostro) il tributo spontaneo d’una sempre viva ammirazione, può prendersi anch’essa qual prova di bellezza e di bellezza assai rara.
Se non che, trattandosi de' Promessi Sposi, par quasi che questo nome di bellezza si adoperi in un senso tutto particolare. Non tanto, cioè, a significar certi pregi esterni e appariscenti, come ad additar qualche cosa d’intimo e di segreto, che si rivela a poco a poco, e affeziona più che non seduce.
E forse potrebbe dirsi che la bellezza de’ Promessi Sposi è ancor più morale che letteraria. Avvi in quest’opera un senno, una calma, una bontá; una conoscenza sì fine degli uomini e delle cose, un giudizio sì equo del loro valore, un culto sì schietto dell’umanità e della virtù, che i lettori ne ricevono un’impressione gratissima quasi indipendentemente dalle sue forme.
L’impressione però sarebbe assai debole, se le forme fossero meno di quel che sono in armonia colle qualità che si son dette. Ma un’armonia sì desiderabile quasi non potea mancare. Quel senno, quella calma, quella bontà dovean naturalmente unirsi al gusto più sano, manifestarsi sotto forme scelte, pure, direi quasi ideali.
E qui può notarsi una gran differenza che passa fra i Promessi Sposi e le più celebri composizioni del gran romanziere, che molti pensano aver servito loro di tipo. Poichè se in queste composizioni trovasi una ricchezza, una varietà, una vita, di cui senza di esse per avventura non si avrebbe nemmeno l'idea; se il gusto in esse pure generalmente parlando, è molto sano; è però meno severo, meno fedele alle ragioni del bello che ne’ Promessi Sposi.
Un’altra differenza, ancor più sensibile, sarà anche più facilmente avvertita. Walter-Scott, ha già detto qualcuno, va dalla storia al romanzo, Manzoni dal romanzo alla storia. Da questo loro andamento diverso risulta, che ciò, che nelle composizioni dell’uno forma, per così dire, lo sfondo delle composizioni medesime, in quella dell’altro forma il soggetto principale.
Quindi non fa meraviglia ciò che da un anno si va bucinando, e in un giornale assai recente si narra senza mistero, che il Manzoni in uno scritto, che verrà presto alla luce, sul romanzo storico, si separi interamente da Walter-Scott. Può egli non separarsene in teorica quando in pratica ne va tanto lontano?
S’egli ha associato il romanzo alla storia, l’ha associato verosimilmente per riguardo alla frivolezza o alla svogliatezza di quelli che senza l’allettativo dell’uno mai non si sarebbero accostati all’altra. Egli ha servito per così dire ad una convenienza momentanea; e ciò ha fatto intendere abbastanza, non solo subordinando alla storia il romanzo, ma serbando fra l’uno e l’altra una chiarissima distinzione.
Da questa intanto è venuta certa duplicità d’interesse, che taluno chiama il grande inconveniente del romanzo storico in generale, io il semplice effetto di combinazioni particolari. Ove è vera fusione del romanzo e della storia, come nelle più celebri composizioni di Walter-Scott; ove la storia prende decisamente il colore del romanzo, o il romanzo della storia, non parmi che manchi nè possa mancare bastante unità, quell’unità, di cui è forza che l’arte si accontenti.
Però chi in uno scritto sul romanzo storico non guardi che al metodo speciale, con cui sono composti i Promessi Sposi, avrà ragione d’insistere sull’inconveniente ch’io accennava. Chi guardi al metodo di comporre seguito da Walter-Scott, al metodo più comune, si limiterà forse ad esaminare se dall'unione del romanzo colla storia ne venga, come talun dice, altro che scapito all’invenzione o alla verità.
Dello scapito, che può venirne all’invenzione, non credo che debba temer molto chi ha già mostrato e teoricamente e col fatto che la storia è la più bella fonte d’invenzione drammatica. Dello scapito, che può venirne alla verità, avrebbe qualche diritto di mostrarsi timoroso chi ha scritto il Discorso sulla Storia de’ Longobardi in Italia, discorso ove il gusto della verità è un poco più manifesto che in certa Vita che sarà forse rifatta, in occasione d’aggiungervi non so che traslazione inaspettata da Longwood alla Piazza Vendôme.
Del resto l’autor della Vita non è meno dotto nella storia patria che l’autor del Discorso. E ch’egli abbia sempre ne’ suoi romanzi falsificato la storia, com’è stato asserito pocanzi da un critico molto avverso al romanzo storico, è un po’ difficile a credersi. Chi ha descritto la peste di Milano darà forse altra sentenza a chi ha descritte le prigioni d’Edimburgo; chi ha dipinto il card. Federigo Borromeo penserà forse che non abbia tanto falsificato, quanto migliorato la storia chi ha dipinto Maria Stuarda.
Ma sia pur evidente che ciascun di loro si è allontanato affatto dal vero. L’autore de' Promessi Sposi ammetterà egli che per l’autore d’un romanzo storico il non allontanarsene sia assolutamente impossibile? Dirà anch’egli che, se scrivendo tragedia o poema epico può fondarsi sulla storia una bella finzione, scrivendo romanzo e impiegandovi la storia non si fà che convertire la storia in falsità?
Non sarebbe forse inutile, trattandosi di romanzo storico, il cercare quali soggetti propriamente possano dalla storia trasferirsi al romanzo, poichè non tutti sicuramente gli convengono del pari, come non tutti convengono alla tragedia o al poema epico. Ma questa questione è subordinata a quella del metodo con cui può associarsi al romanzo la storia, giacchè in un romanzo ove la storia tien posto principale e distinto, quasi ogni soggetto è ammissibile, e ammissibile con tutte le sue particolarità.
Molte particolarità sì storiche e sì di pura invenzione so essere state ommesse come soverchie nella traduzione francese de' Promessi Sposi, e forse con giusto avvedimento. Con pari avvedimento saranno state serbate, spero, tutte le analisi morali, che sono la terza gran differenza che può notarsi fra il comporre del Manzoni e di Walter-Scott. Questi per solito fa indovinar le cause dipingendo mirabilmente gli effetti; l’altro cerca ne’ ripostigli della mente e del cuore le cause stesse, e accennandole e descrivendole tocca infinite cose de' bisogni, degli errori, delle sciagure degli uomini, con un senso di pietà che veramente commove.
In queste analisi, più ancora che in altre parti, ei mostra quella potenza d’eloquio, che fa di lui uno de’ nostri scrittori più ammirabili. Tal potenza è sovente circoscritta dalla mancanza di segni opportuni per significare ciò ch’egli ha nell’animo o nel pensiero. Nella patria del Davanzati egli che, non ostanti alcune divergenze, ha con questo scrittore molti principii comuni, chi sa come avrebbe espresso mille e mille cose, cui ha dovuto esprimere per via di supplementi? In questi supplementi, peraltro, quant’ingegno, quant’arte, e spesso quanta felicità!
Le cose qui accennate sarebbero materia, ciascuna per sè, di lungo discorso. Ma nè questo forse bisogna, nè io, per ora almeno, vi sono menomamente disposto. Io non ho avuto in animo che d’annunciare la doppia edizione annunciata infatti pocanzi, e gettar per così dire un fiore sulla più grandicella specialmente, ch'è vero fiore dell'arte. Se mai, pubblicando il suo romanzo, l’autore amò ripeter fra sè quei versi del suo inno ad Urania: O sacri colli, o d’Arno — Sposa gentil, che a te gradito ei vegna — Chieggo ec.; la doppia edizione qui annunziata lo assicura che il suo voto è pienamente adempito.
M.
