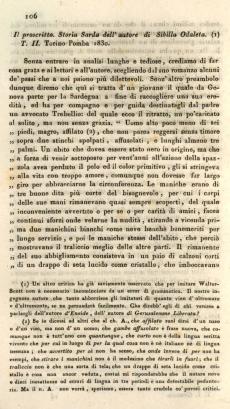
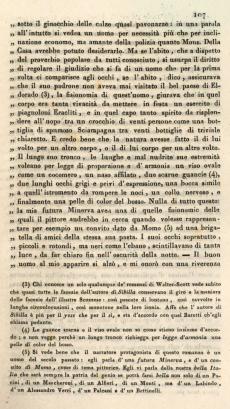
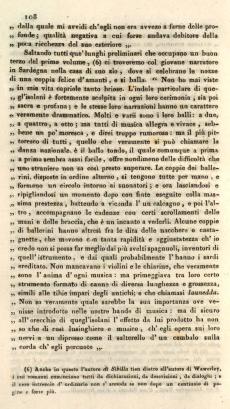
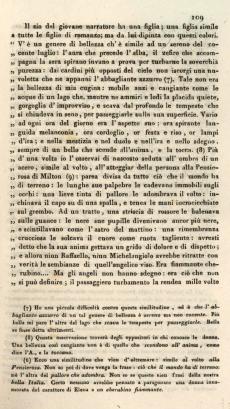
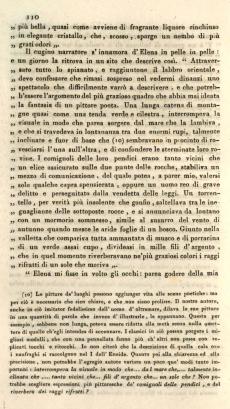
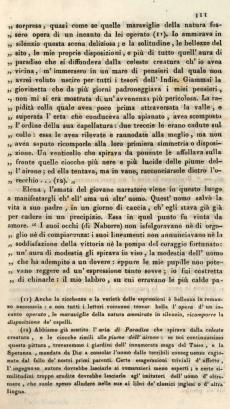
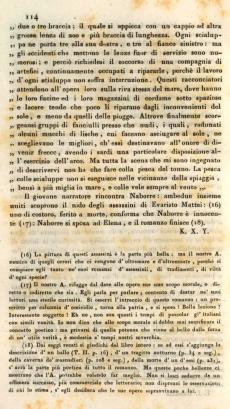
l proscritto. Storia Sarda dell'autore di Sibilla Odaleta. (I) T. II. Torino Pomba 1830.
Senza entrare in analisi lunghe e tediose, crediamo di far cosa grata e ai lettori e all'autore, scegliendo dal suo romanzo alcuni de' passi che a noi paiono più dilettevoli. [...] "Ma se l'abito, che a dispetto del proverbio popolare da tutti conosciuto, si usurpa il diritto di regolare il giudizio che si fa di un uomo che per la prima volta ci comparisce agli occhi, se l'abito, dico, assicurava che il suo padrone non aveva mai visitato il bel paese di El-dorado (3), la fisionomia di quest'uomo, giurava che in quel corpo era tanta vivacità da mettere in festa un esercito di piagnoloni Eracliti, e in quel capo tanto spirito da risplendere all'uopo tra un crocchio di venti persone come una bottiglia di spumoso Sciampagna tra venti bottiglie di triviale chiaretto. [...]"
Saltando tutti que' lunghi preliminari che occupano un buon terzo del primo volume, (6) ci troveremo col giovane narratore in Sardegna nella casa di suo zio, dove si celebrano le nozze di una coppia felice d'amanti, e si balla. [...]
"Più d'una volta io l'osservai di nascosto seduta all'ombra di un acero, simile al volto, all'atteggiar della persona alla Pensierosa di Milton (9): parea divisa da tutto ciò che il mondo ha di terreno: le lunghe sue palpebre le cadevano immobili sugli occhi: una lieve tinta di pallore le adombrava il volto: inchinava il capo su di una spalla, e tenea le mani incrocicchiate sul grembo. [...]"
"Una lunga catena di montagne quasi come una tenda verde e cilestra, interrompeva la visuale in modo che parea sorgere dal mare che la lambiva e che si travedeva in lontananza tra due enormi rupi, talmente inclinate e fuor di base che (10) sembravano in procinto di rovesciarsi l'una sull'altra, e di confondere le sterminate loro rovine. [...]
Un venticello che spirava da ponente le affollava sulla fronte quelle ciocche più nere e più lucide delle piume dell'airone; ed ella tentava, ma in vano, racconciarsele dietro l'orecchio... (12)."
[...]
Il giovane narratore rincontra Naborre: ambedue insieme uniti scoprono il nido degli assassini di Evaristo Mattei: (16) uno di costoro, ferito a morte, conferma che Naborre è innocente (17): Naborre si sposa ad Elena, e il romanzo finisce (18).
K. X. Y.
(I) Un altro critico ha già saviamente osservato che per imitare Walter-Scott non è necessario incominciare da un error di grammatica. Il nostro ingegnoso autore che tanto abborrisce gli imitatori di quanto vien d'oltremare e d'oltremonte, se ne persuaderà facilmente. Che direbbe egli di chi venisse a parlargli dell'autore d'Eneide, dell'autore di Gerusalemme Liberata?
(3) Chi conosce un solo qualunque de' romanzi di Walter-Scott vede subito che quasi tutte le facezie dell'autore di Sibilla conservano il giro o la maniera delle facezie dell'illustre Scozzese: così pescate di lontano, così ravvolte in lunghe circonlocuzioni, così monotone nella loro ironia. Affè che l'autore di Sibilla è più per il yess che per il sì, e sta d'accordo con quel Baretti ch'egli chiama pedante.
(6) Anche in questo l'autore di Sibilla tien dietro all'autore di Wawerley, i cui romanzi cominciano tutti da dichiarazioni, da descrizioni, da dialoghi; e il vero intreccio d'ordinario non s'annoda se non dopo un centinaio di pagine e forse più.
(6) Ecco una similitudine che vien d'oltremare: simile al volto alla Pensierosa. Non so poi di dove venga la frase: ciò che il mondo ha di terreno: né l'altra del pallore che adombra. Non so se queste sien frasi della nostra bella Italia. Certo nessuno avrebbe pensato a paragonare una donna innamorata del carattere di Elena a un cherubino fiammante.
(10) Le pitture de' luoghi possono aggiunger vita alle scene poetiche: ma per ciò è necessario che sien chiare, e che non sieno prolisse. Il nostro autore, anche in ciò imitator fodelissimo dell'uomo d'oltremare, dilava le sue pitture in una quantità di parole che invece d'illustrarle, le appannano. Questa per esempio, sebbene non lunga, poteva essere ridotta alla metà senza nulla omettere di quello ch'egli intendea di accennare. I classici in ciò posson porgere i migliori modelli; che con una pennellata fanno più ch'altri non possa con replicati tocchi e ritocchi. Io non citerò che la descrizione di quella cala ove i naufraghi si raccolgono nel I dell'Eneide. Quanto poi alla chiarezza ed alla precisione, non potrebbe l'egregio autore variare un poco que' modi tanto importuni: interrompeva la visuale in modo che... dal mare che,.... talmente inclinata che,.... tanto vicini che... fili d'argento che... un sole che? Non potrebbe scegliere espressioni più pittoresche de' comignoli delle pendici, e del riverbero dei raggi rifratti?
(12) Abbiamo già sentito l'aria di Paradiso che spirava dalla celeste creatura, o le ciocche simili alle piume dell'airone: se noi continuassimo questa pittura, troveremmo i giardini dell'innamorata maga del Tasso, e la Speranza, mandata da Dio a consolar l'uomo dalle terribili conseguenze cagionate dal fallo de' nostri primi parenti. Certe esagerazioni triviali d'affetto, l'ingegnoso autore dovrebbe lasciarle ai romanzieri mono esperti; e certe similitudini troppo erudite dovrebbe lasciarle agl' imitatori dell'uomo d'oltremare, che suole spesso alludere nelle sue ai libri de' classici inglesi o d'altra lingua.
(16) La pittura di questi assassini è la parte più bella; ma il nostro A. nemico di quegli orrori che ci vengono d'oltremare e d'oltremonte, perchè si compiace egli tanto ne' suoi romanzi d'assassinii, di tradimenti, di viltà d'ogni specie?
(17) Il nostro A. rifugge dal dare allo opere suo uno scopo morale, o diretto o indiretto che sia. Egli parla per parlare; contento di destar ne' suoi lettori una sterile curiosità. Si osservi l'intreccio di questo romanzo; un proscritto per calunnia d'omicidio, torna alla patria, e si sposa! Bella lezione! Interessante soggetto! Eh no, non son questi i tempi di pascolar gl'italiani con simili vanità. Io non dico che allo scopo morale si debba mai sacrificare il concetto poetico: ma privarsi di quella potenza che viene al bello dalla forza di un'utile verità, è modestia a' tempi nostri soverchia.
(18) Dai saggi recati si giudichi del libro intero: se ad essi s'aggiunga la descrizione d'un ballo (T. II. p. 16), d'un tragitto notturno (p. 34 e seg.), della caverna de' masnadieri (p. 108 e seg.), della morte d'un d'essi (p. 231), s'avrà la parte più poetica di tutto il romanzo. Ma queste poche bellezze ci mostrano che l'A. potrebbe volendo far meglio. Non si lasci sedurre da un effimero successo, più commerciale che letterario; non disprezzi le osservazioni di chi lo stima, s'egli desidera che le sue opere sopravvivano a lui.
