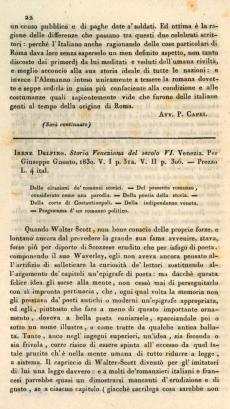
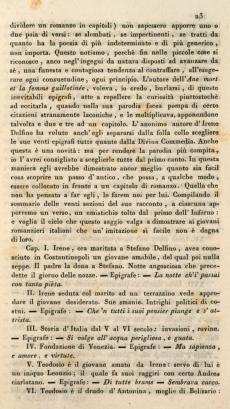

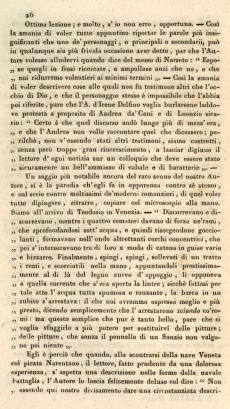
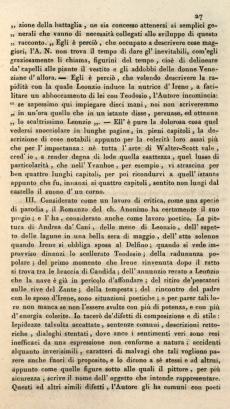
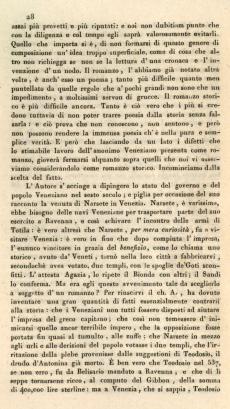
IRENE DELFINO. Storia Veneziana del secolo VI. Venezia. Per Giuseppe Gnoato, 1830. V. I p. 312. V. II p. 306. — Prezzo L. 4 ital.
Delle citazioni de' romanzi storici. — Del presente romanzo, considerato come una parodia. — Della poesia della storia. — Della corte di Costantinopoli. — Della indipendenza veneta. — Programma d'un romanzo politico.
Quando Walter Scott, non bene conscio delle proprie forze, e lontano ancora dal prevedere la grande sua fama avvenire, stava, forse più per diporto di Scozzese erudito che per isfogo di poeta, componendo il suo Waverley, egli non aveva ancora pensato all'artifizio di solleticare la curiosità de' lettori sostituendo all'argomento de' capitoli un'epigrafe di poeta: ma dacchè questa felice idea gli sorse alla mente, non cessò mai di perseguitarlo con sì impronta pertinacia, che, ogni qual volta la memoria non gli prestava da' poeti antichi o moderni un'epigrafe appropriata, ed egli, piuttosto che fare a meno di questo importante ornamento, doveva a bella posta coniarsele, spacciandole poi o sotto un nome illustre, o come tratte da qualche antica ballata. Tanto, anco negl'ingegni superiori, un'idea, sia feconda o sia frivola, corre risico di essere spinta all'eccesso da quel fatale prurito ch'è nella mente umana di tutto ridurre a legge, a sistema. Il capriccio di Walter-Scott diventò per gl'imitatori di lui una legge davvero: e a molti de' romanzieri italiani e francesi parrebbe quasi un dimostrarsi mancanti d'erudizione e di gusto, se a ciascun capitolo (giacchè sacrilega cosa sarebbe non dividere un romanzo in capitoli) non sapessero apporre uno o due paia di versi: se slombati, se impertinenti, se tratti da quanto ha la poesia di più indeterminato e di più generico, non importa. Questo notiamo, perchè fin nelle piccole cose si riconosce, anco negl'ingegni da natura disposti ad avanzare da sè, una funesta e contagiosa tendenza al contraffare, all'esagerare ogni consuetudine, ogni principio. L'autore dell' Ane mort et la femme guillotinée, voleva, io credo, burlarsi, di queste inevitabili epigrafi, atte a repellere la curiosità piuttostochè ad eccitarla, quando nella sua parodia facea pompa di certe citazioni stranamente laconiche, e le moltiplicava, apponendone talvolta e due e tre ad un capitolo. L'anonimo autore d'Irene Delfino ha voluto anch'egli separarsi dalla folla collo scegliere le sue venti epigrafi tutte quante dalla Divina Commedia. Anche questa è una novità: ma per rendere la parodia più compita, io l'avrei consigliato a sceglierle tutte dal primo canto. In questa maniera egli avrebbe dimostrato ancor meglio quanto sia facil cosa scoprire un passo d'antico, che possa, a qualche modo essere collocato in fronte a un capitolo di romanzo. [...]
Nè crediamo già che non si possa in un romanzo, in qualunque sia scritto, scegliere ed adattare con originalità e con sapienza un'epigrafe, quasi testo eloquente alle cose che lo scrittore s'accinge ad esporre: ma quel volerle per regola indeclinabile , quel farsene un preciso dovere, e poi quello sceglierle con tanta negligenza, appunto come i più sogliono sdebitarsi di un dovere arduo ed incomodo, non so se sia difetto da doversi più a lungo passare sotto silenzio.
II. Certo è che de' difetti ormai resi comuni a tutti quasi i romanzi storici, il nostro autore si dimostra in quest'opera osservatore assennato e sincero: come quando della propria storia esclama con manzoniana ingenuità: "la bella istoria davvero per chi non ne conoscesse altre!" — Quando, ripigliando il filo della intralasciata narrazione: "Ma per tornare alla nostra storia, o romanzo, ch'è spesse volte lo stesso". — Quando di un vezzo sistematico dei più tra i romanzieri, si ride graziosamente così. "Ora la moda comanda e vuole che in lavori del genere di quello che abbiamo fra mano, si metta ad ogni costo del mistero: e noi, quasi che credessimo di non avere altri e più gravi peccati addosso, ci siamo impegnati ad obbedire al suo decreto in questo, e fino a questo punto, perchè dell'avvenire non sentiamo di poterci compromettere sulla nostra costanza. Non già che il mistero non sia un ingrediente piccantissimo: vi sono anzi moltissimi intingoli, lavorati con tutta la maestria degli Apicii i più sperimentati, che guai se si sospettasse innanzi tratto le mot de l'énigme: tutto il sapore loro svanirebbe... Del che noi potremmo citare parecchi esempi, se il rispetto che a nomi e a cose professiamo, non ci trattenesse da ogni specifica individuazione. E quel volervelo ficcare a qualunque patto: è quel prendere a sua cagione le vie più contorte e precipitose, quando quella dei carri servirebbe assai meglio al rapido svolgimento delle idee dello scrittore: è quel parlare a mezza bocca, mentre coll'ore rotundo i pazienti lettori lo ascolterebbero più volentieri, ed a maggior profitto: sono tutte queste cose insieme, ed altre ancora che ci passano per la mente, ma che per tema d'annoiar noi ed altrui, non ci vien voglia di mettere in carta, queste sono che non ci garbano nè punto nè poco".
Ottima lezione; e molto, s'io non erro, opportuna. — Così la smania di voler tutte appuntino riportar le parole più insignificanti che uno de' personaggi, o principali o secondarii, può in qualunque sia più frivola occasione aver dette, par che l'Autore volesse alludervi quando dice del messo di Narsete: "Espose quegli in frasi ricercate, e ampollose anzi che no, e che noi ridurremo volentieri ai minimi termini". — Così la smania di voler descrivere cose alle quali non fu testimone altri che l'occhio di Dio, e che il personaggio stesso è impossibile che l'abbia poi riferite, pare che l'A. d'Irene Delfino voglia burlarsene laddove protesta a proposito di Andrea da' Cani e di Leonzio sicario: "Certo è che quel discorso andò lungo più di mezz'ora, e che l'Andrea non volle raccontare quel che dicessero; perilchè, non v'essendo stati altri testimoni, siamo costretti, senza però troppo gran rincrescimento, a lasciar digiuno il lettore d'ogni notizia sur un colloquio che deve essere stato sicuramente un bell'ammasso di cabale e di baratterie". —
Un saggio più notabile ancora del raro senno del nostro Autore, si è la parodia ch'egli fa in apparenza contro sè stesso e sul serio contro moltissimi de' moderni romanzieri, di quel voler tutto dipingere, ritrarre, copiare col microscopio alla mano. Siamo all'arrivo di Teodosio in Venezia. — "Discorrevano e discorrevano, mentre i quattro rematori davano di forza ne' remi, che sprofondandosi sott'acqua, e quindi risorgendone gocciolanti, formavano nell' onde altrettanti cerchi concentrici, che poi s'intersecavano tra di loro a modo di catena in guise varie e bizzarre. Finalmente, spingi, spingi, sollevati di un tratto i remi, e scorciatili nella mano, appuntandoli prestissimamente al di là del legno curvo d'appoggio, li opponeva a quella corrente che s'era aperta la lintre; sicchè fattasi per tale atto l'acqua tutta spumosa e ronzante, la barca in un subito s'arrestava: il che noi avremmo espresso meglio e più presto, dicendo semplicemente che l'arrestarono sciando co' remi: ma questo semplice che pur è tanto bello, pare che si voglia sfuggirlo a più potere per sostituirvi delle pitture; delle pitture, che senza il pennello di un Sanzio non valgono poi niente".
Egli è perciò che quando, allo scontrarsi della nave Veneta col pirata Narentano, il lettore, fatto prudente da una dolorosa esperienza, s'apetta una descrizione nelle forme della navale battaglia, l'Autore lo lascia felicemente deluso col dire: "Non essendo qui nostro divisamento dare una circostanziata descrizione della battaglia, ne sia concesso attenersi ai semplici generali che vanno di necessità collegati allo sviluppo di questo racconto." Egli perciò, che occupato a descrivere cose maggiori, l'A. N. non trova il tempo di dare gl'inevitabili, com'egli graziosamente li chiama, figurini del tempo, cioè di delineare da' capelli alle piante il vestito e gli addobbi delle donne Veneziane d'allora. — Egli è perciò, che volendo descrivere la rapidità con la quale Leonzio induce la nutrice d'Irene, a facilitare un abboccamento di lei con Teodosio, l'Autore incomincia: "se sapessimo qui impiegare dieci mani, noi non scriveremmo in un'ora quello che in un istante disse, persuase, ed ottenne lo scaltrissimo Leonzio". — Ell'è pure la dolorosa cosa quel vedersi snocciolare in lunghe pagine, in pieni capitoli, la descrizione di cose notabili appunto per la celerità loro assai più che per l'importanza: nè tutta l'arte di Walter-Scott vale, cred'io, a render degna di lode quella esattezza, quel lusso di particolarità, che nell'Yvanhoe, per esempio, vi strascina per en quattro lunghi capitoli, per poi ricondurvi a quell'istante appunto che fu, innanzi ai quattro capitoli, sentito non lungi dal castello il suono d'un corno.
III. Considerato come un lavoro di critica, come una specie di parodia, il Romanzo del ch. Anonimo ha certamente il suo pregio; e l'ha, considerato anche come lavoro poetico. La pittura di Andrea da' Cani, delle mene di Leonzio, dell'aspetto delle lagune in una bella sera di maggio, dell'atto solenne quando Irene si obbliga sposa al Delfino; quando si vede improvviso dinanzi lo scellerato Teodosio; della radunanza popolare; del primo momento che Irene rinvenuta dopo il ratto si trova tra le braccia di Candida; dell'annunzio recato a Leonzio che la nave è già in pericolo d'affondare; del ritiro de' pescatori sulle rive del Zante; della tempesta; del rincontro del padre con lo sposo d'Irene, sono situazioni poetiche; e per parer tali loro non manca se non l'essere svolte con più di potenza, e con più d'energia colorite. Io tacerò de' difetti di composizione e di stile: lepidezze talvolta accattate, sentenze comuni, descrizioni rettoriche, dialoghi stentati, dove anco i sentimenti veri sono resi inefficaci da una espressione non conforme a natura; accidenti alquanto inverisimili, caratteri di malvagi che tali vogliono parere anche fuori di proposito, e lo dicono a sè stessi e ad altrui, appunto come quelle figure sotto alle quali il pittore, per più sicurezza, scrive il nome dell'oggetto che intende rappresentare. Questi ed altri simili difetti, l'Autore gli ha comuni con poeti assai più provetti e più riputati: e noi non dubitiam punto che con la diligenza e col tempo egli saprà valorosamente evitarli. Quello che importa si è, di non formarsi di questo genere di composizione un'idea troppo superficiale, come di cosa che altro non richiegga se non se la lettura d'una cronaca e l'invenzione d'un nodo. Il romanzo, l'abbiamo già notato altra volta, è anch'esso un poema; tanto più difficile quanto men puntellato da quelle regole che a' pochi grandi non sono che un impedimento, a moltissimi servon di grucce. Il romanzo storico è più difficile ancora. Tanto è ciò vero che i più si credono tuttavia di non poter trarre poesia dalla storia senza falsarla: e ciò prova che non conoscono, non sentono, e però non possono rendere la immensa poesia ch'è nella pura e semplice verità. [...]
