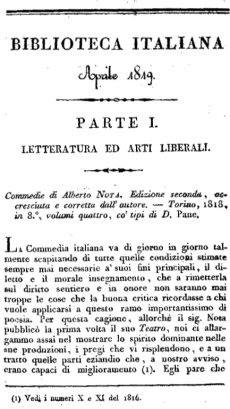
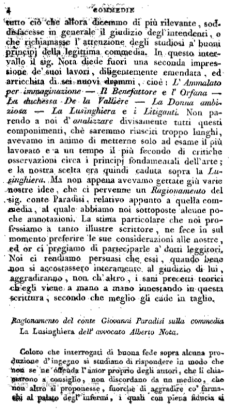
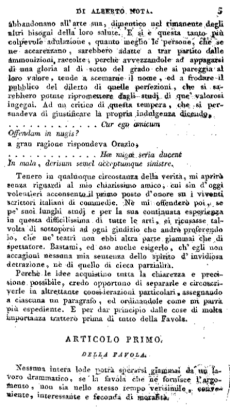
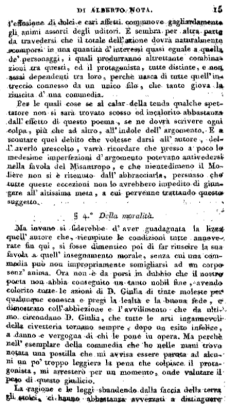
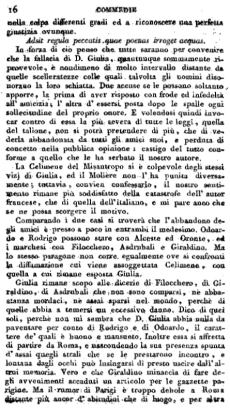
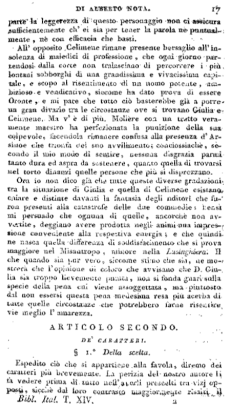
Commedie di Alberto NOTA. Edizione seconda, accresciuta e corretta dall'autore. – Torino, 1818, in 8.°, volumi quattro, co' tipi di D. Pane.
La Commedia italiana va di giorno in giorno talmente scapitando di tutte quelle condizioni stimate sempre mai necessarie a' suoi fini principali, il diletto e il morale insegnamento, che a rimetterla sul diritto sentiero e in onore non saranno mai troppe le cose che la buona critica ricordasse a chi vuole applicarsi a questo ramo importantissimo di poesia. Per questa cagione, allorchè il sig. Nota pubblicò la prima volta il suo Teatro, noi ci allargammo assai nel mostrare lo spirito dominante nelle sue produzioni, i pregi che vi risplendono, e a un tratto quelle parti eziandio che, a nostro avviso, erano capaci di miglioramento (I). Egli pare che tutto ciò che allora dicemmo di più rilevante, soddisfacesse in generale il giudizio degl'intendenti, o che richiamasse l'attenzione degli studiosi a' buoni principj della legittima commedia. In questo intervallo il sig. Nota diede fuori una seconda impressione de' suoi lavori, diligentemente emendata, ed arricchita di sei nuovi drammi, cioè: L'Ammalato per immaginazione – Il Benefattore e l'Orfana – La duchessa De la Vallière – La Donna ambiziosa – La Lusinghiera e i Litiganti. Non parendo a noi d'analizzare divisamente tutti questi componimenti, chè saremmo riusciti troppo lunghi, avevamo in animo di metterne solo ad esame il più lavorato e a un tempo il più fecondo di critiche osservazioni circa i principj fondamentali dell'arte; e la nostra scelta era quindi caduta sopra la Lusinghiera. Ma non appena avevamo gettate giù varie nostre idee, che ci pervenne un Ragionamento del sig. conte Paradisi, relativo appunto a quella commedia, al quale abbiamo noi sottoposte alcune poche annotazioni. La stima particolare che noi professiamo a tanto illustre scrittore, ne fece in sul momento preferire le sue considerazioni alle nostre, ed or ci pregiamo di parteciparle a' dotti leggitori. Noi ci rendiamo persuasi che essi, quando bene non si accostassero interamente al giudizio di lui, aggradiranno, non ch'altro, i sani precetti teorici ch'egli viene a mano a mano innestando in questa scrittura, secondo che meglio gli cade in taglio.
Ragionamento del conte Giovanni Paradisi sulla commedia La Lusinghiera dell'avvocato Alberto Nota.
Coloro che interrogati di buona sede sopra alcuna produzione d'ingegno si studiano di rispondere in modo che non se ne offenda l'amor proprio degli autori, che li chiamarono a consiglio, non discordano da un medico, che non altro si proponesse, fuorchè di aggradire co' farmachi al palato degl'infermi, i quali con piena fiducia si abbandonano all'arte sua, dimentico nel rimanente degli altri bisogni della loro salute. E si è questa tanto più colpevole adulazione, quanto meglio le persone, che se ne accarezzano, sarebbero adatte a trar partito dalle ammonizioni, raccolte, perchè avvezzandole ad appagarsi di una gloria al di sotto del grado che si pareggia al loro valore, tende a scemarne il nome, ed a frodare il pubblico del diletto di quelle perfezioni, che si sarebbero potute ripromettere dagli studi di que' valorosi ingegni. Ad un critico di questa tempera, cha si persuadava di giustificare la propria indulgenza dicendo,
.............Cur ego amicum Offendam in nugis?
a gran ragione rispondeva Orazio,
.............Hoe migae seria ducent In mala, derisum semel acceptumque sinistre.
Tenero in qualunque circostanza della verita, mi aprirò senza riguardi al mio chiarissimo amico, cui sin d'oggi volentieri acconsento il primo posto d'onore su i viventi scrittori italiani di commedie. Ne mi offenderò poi, se pe' suoi lunghi studi e per la sua continuata esperienza in questa difficilissima di tutte le arti, ei ricusasse tal volta di sottoporsi ad ogni giudizio che andrè proferendo io, che ne' teatri non ebbi altra parte giammai che di spettatore. Bastami, ed oso anche esigerlo, ch'egli non accagioni nessuna mia sentenza dello spirito d'invidiosa detrazione, nè di quello di cieca parzialità.
Perchè le idee acquistino tutta la chiarezza e precisione possibile, credo opportuno di separarle e circoscriverle in altrettante considerazioni particolari, assegnando a ciascuna un paragrafo, ed ordinandole come mi parrà più espediente. E per dar principio dalle cose di molta importanza tratterò prima di tutto della Favola.
ARTICOLO PRIMO.
DELLA FAVOLA.
Nessuna intera lode potrà sperarsi giammai da un lavoro drammatico, se la favola che ne fornisce l'argomento, non sia nello stesso tempo verisimile, conveniente, interessante e feconda di moralità.
[...]
§ 4.° Della moralità.
Ma invano si fiderebbe d'aver guadagnata la lizza quell'autore che, riempiute le condizioni tutte annoverate sin qui, si fosse dimentico poi di far riuscire la sua favola a quell' insegnamento morale, senza cui una commedia può non impropriamente somigliarsi ad un corpo senz'anima. Ora non è da porsi in dubbio che il nostro poeta non abbia conseguito un tanto nobil fine, avendo colorito tutte le azioni di D. Giulia di tinte moleste per qualunque conosca o pregi la lealtà e la buona fede, dimostrato coll'abbiezione e l'avvilimento che da ultimo circondano D. Giulia, che tutte lo arti ingannevoli della civetteria tornano sempre, dopo un esito infelice, a danno e vergogna di chi le pone in opera. Ma perchè nell'esemplare della commedia che ho nelle mani trovo notata una postilla che mi avvisa essere paruta ad alcuni un po' troppo leggiera la pena che colpisce il protagonista, mi arresterò per un momento, onde valutare il peso di questo giudicio.
La ragiono e le leggi sbandendo dalla faccia della terra gli stolti, ci hanno abbastanza avvezzati a distinguere nella colpa differenti gradi ed a riconoscere una perfetta giustizia ovunque.
Adsit regula peccatis quae poenas irroget aequas.
In forza di ciò penso che tutte saranno per convenire che la fallacia di D. Giulia, quantunque sommamente riprovevole, è nondimeno di molto intervallo distante da quelle scelleratezze colle quali talvolta gli uomini disonorano la loro schiatta. Due accuse se le possono soltanto apporre, la prima di aver risposto con frode ed infedeltà all'amicizia, l'altra d'essersi posta dopo le spalle ogni sollecitudine del proprio onore. E volendosi quindi invocar contro di essa la più severa di tutte le leggi, quella del talione, non si potrà pretendere di più, che di vederla abbandonata da tutti gli amici suoi, e perduta di concetto nella pubblica opinione: castigo del tutto conforme a quello che le ha serbato il nostro autore.
La Celimene del Misantropo si è colpevole degli stessi vizi di Giulia, ed il Molière non l'ha punita diversamente; tuttavia, convien confessarlo, il nostro sentimento rimane più soddisfatto della catastrofe dell'autor francese, che di quella dell'italiano, e mi pare anco che se ne possa scorgere il motivo.
Comparando i due casi si troverà che l'abbandono degli amici è presso a poco in entrambi il medesimo. Odoardo e Rodrigo possono stare con Alceste ed Oronte, ed i marchesi con Filocchero, Asdrubali e Giraldino. Ma lo stesso paragone non corre egualmente ove si confronti la diffamazione cui viene assoggettata Celimene, con quella a cui rimane esposta Giulia.
Giulia rimane scopo alle dicerie di Filocchero, di Giraldino, di Asdrubali che non sono comparsi, nè abbastanza mordaci, nè assai sparsi nel mondo, perchè di quelle abbia a temersi un eccessivo danno. Dico di quei soli, perchè non mi sembra che D. Giulia abbia nulla da paventare per conto di Rodrigo e di Odoardo, il carattere de' quali è buono e mansueto. Inoltre essa si affretta di partire da Roma, e nascondendo la sua presenza spunta d'assai quegli strali che se le prestarono incontro, e lontana dagli occhi può lusingarsi di presto uscire dall'altrui memoria. Vero e che Giraldino minaccia di fare degli avvenimenti accaduti un articolo per le gazzette parigine. Ma il rumor di Parigi è troppo debole a Roma distante più ancor d'abitudini che di luogo, e per altra parte la leggerezza di questo personaggio non ci assicura sufficientemente ch'ei sia per tener la parola nè puntualmente, nè con efficacia che basti.
All'opposito Celimene rimane presente bersaglio all'insolenza di maledici di professione, che ogni giorno partendosi dalla corte non tralasciano di percorrere i più lontani sobborghi di una grandissima e vivacissima capitale, e scopo al risentimento di un uomo potente, ambizioso e vendicativo, siccome ha dato prova di essere Oronte, e mi pare che tutto ciò basterebbe già a porre un gran divario tra le circostanze ove si trovano Giulia e Celimene. Ma v'è di più. Molière con un tratto veramente maestro ha perfezionata la punizione della sua colpevole, facendola rimanere confusa alla presenza d'Arsinoe che trionfa del suo avvilimento; conciossiachè, secondo il mio modo di sentire, nessuna disgrazia parmi tanto dura ed aspra da sostenere, quanto quella di trovarsi nel torto dinanzi quelle persone che più si disprezzano.
Ora io non dico già che tutte queste diverse gradazioni tra la situazione di Giulia e quella di Celimene esistano chiare e distinte davanti la fantasia degli uditori che furon presenti alla catastrofe delle due commedie: bensì mi persuado che ognuna di quelle, ancorchè non avvertite, deggiano avere prodotta negli animi una impressione conveniente alla respettiva energia; e che quindi ne nasca quella difforenza di soddisfacimento che si prova maggiore nel Misantropo, minore nella Lusinghiera. Il che quando sia pur vero, siccome stimo che sia, ne mostrerà che l'opinione di coloro che avvisano che D. Giulia sia troppo lievemente punita, non si fonda guari sulla specie della pena cui viene assoggettata, ma piuttosto dal non essersi questa pena medesima resa più acerba di tutte quelle circostanze che potrebbero farne risentire vie meglio l'amarezza.
[...]
(I) Vedi i numeri X e XI del 1816.
