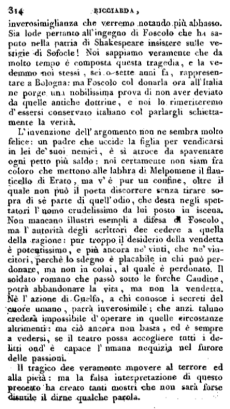
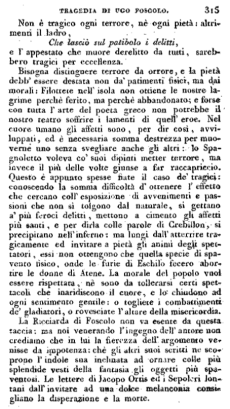
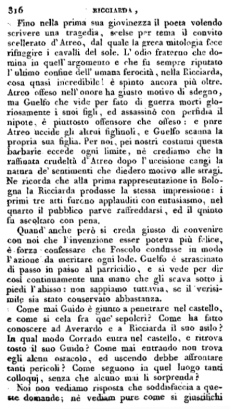
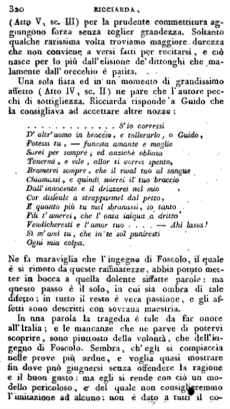
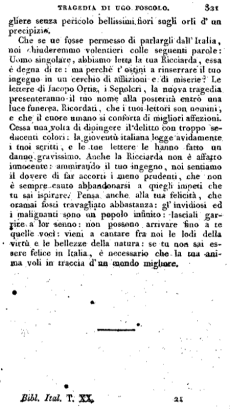
[...]
L'invenzione dell'argomento non ne sembra molto felice: un padre che uccide la figlia per vendicarsi in lei de' suoi nemici, è sì atroce da spaventare ogni petto più saldo: noi certamente non siam fra coloro che mettono alle labbra di Melpomene il flauticello di Erato, ma v'è pur un confine, oltre il quale non può il poeta discorrere senza tirare sopra di sè parte di quell'odio, che desta negli spettatori l'uomo crudelissimo da lui posto in iscena. Non mancano illustri esempli a difesa di Foscolo, ma l'autorità degli scrittori dee cedere a quella della ragione: pur troppo il desiderio della vendetta è potentissimo, e più ancora ne' vinti, che ne' vincitori, perchè lo sdegno è placabile in chi può perdonare, ma non in colui, al quale è perdonato. Il soldato romano che passò sotto le forche Caudine, potrà abbandonare la vita, ma non la vendetta. Nè l'azione di Guelfo, a chi conosce secreti del cuore umano, parrà inverosimile; che anzi taluno crederà impossibile d'operare in quelle circostanze altrimenti: ma ciò ancora non basta, ed è sempre a vedersi, se il teatro possa accogliere tutti i delitti ond'è capace l'umana nequizia nel furore delle passioni.
Il tragico dee veramente muovere al terrore ed alla pietà: ma la falsa interpretazione di questo precetto ha creato tanti mostri che non sarà forse disutile il dirne qualche parola.
Non è tragico ogni terrore, nè ogni pietà: altrimenti il ladro,
Che lasciò sul patibolo i delitti,
e l'appestato che muore derelitto da tutti, sarebbero tragici per eccellenza.
Bisogna distinguere terrore da orrore, e la pietà debb'essere destata non da patimenti fisici, ma dai morali: Filottete nell isola non ottiene le nostre lagrime perchè ferito, ma perchè abbandonato; e forse con tutta l'arte del poeta greco non potrebbe il nostro teatro soffrire i lamenti di quell'eroe. Nel cuore umano gli affetti sono, per dir così, avviluppati, ed è necessaria somma destrezza per muoverne uno senza svegliare anche gli altri: lo Spagnoletto voleva co' suoi dipinti metter terrore, ma invece il più delle volte giunse a far raccapriccio. Questo è appunto spesse fiate il caso de' tragici: conoscendo la somma difficoltà d'ottenere l'effetto che cercano coll'esposizione di avvenimenti e passioni che non si tolgono dal naturale, si gettano a' più feroci delitti, mettono a cimento gli affetti più santi, e per dirla colle parole di Crebillon, si precipitano nell'inferno: ma lungi dall'atterrire tragicamente ed invitare a pietà gli animi degli spettatori, essi non ottengono che quella specie di spavento fisico, onde le furie di Eschilo fecero abortire le donne di Atene. La morale del popolo vuol essere rispettata, nè sono da tollerarsi certi spettacoli che inaridiscono il cuore, e lo chiudono ad ogni sentimento gentile: o togliete i combattimenti de' gladiatori, o rovesciate l'altare della misericordia.
La Ricciarda di Foscolo non va esente da questa taccia: ma noi venerando l'ingegno dell'autore non crediamo che in lui la fierezza dell'argomento venisse da impotenza: chè gli altri suoi scritti ne scoprono l'indole sua inclinata ad ornare colle più splendide vesti della fantasia gli oggetti più spaventosi. Le lettere di Jacopo Ortis ed i Sepolcri lontani dall'invitare ad una dolce melanconia consigliano la disperazione e la morte.
Fino nella prima sua giovinezza il poeta volendo scrivere una tragedia, scelse per tema il convito scellerato d'Atreo, dal quale la greca mitologia fece rifuggire i cavalli del sole. L'odio fraterno che domina in quell'argomento e che fu sempre riputato l'ultimo confine dell'umana ferocità, nella Ricciarda, cosa quasi incredibile! è spinto ancora più oltre. Atreo offeso nell' onore ha giusto motivo di sdegno, ma Guelfo che vide per fato di guerra morti gloriosamente i suoi figli, ed assassinò con perfidia il nipote, è piuttosto offensore che offeso: e pure Atreo uccide gli altrui figliuoli, e Guelfo scanna la propria sua figlia. Per noi, pei nostri costumi questa barbarie eccede ogni limite, nè crediamo che la raffinata crudeltà d'Atreo dopo l'uccisione cangi la natura de' sentimenti che diedero motivo alle stragi. Ne ricorda che alla prima rappresentazione in Bologna la Ricciarda produsse la stessa impressione: i primi tre atti furono applauditi con entusiasmo, nel quarto il pubblico parve raffreddarsi, ed il quinto fu ascoltato con pena.
[...]
In una parola la tragedia è tale da far onore all'Italia; e le mancanze che ne parve di potervi scoprire, sono piuttosto della volontà, che dell'ingegno di Foscolo. Sembra, ch'egli si compiaccia nelle prove più ardue, e voglia quasi mostrare fin dove può giugnersi senza offendere la ragione il buon gusto: ma egli si rende con ciò un modello pericoloso, e del quale non consiglieremmo l'imitazione ad alcuno: non è dato a tutti il cogliere senza pericolo bellissimi fiori sugli orli d'un precipizio.
Che se ne fosse permesso di parlargli dall'Italia, noi chiuderemmo volentieri colle seguenti parole: Uomo singolare, abbiamo letta la tua Ricciarda, essa è degna di te: ma perchè t'ostini a rinserrare il tuo ingegno in un cerchio di afflizioni e di miserie? Le lettere di Jacopo Ortis, i Sepolcri, la nuova tragedia presenteranno il tuo nome alla posterità entro una luce funerea. Ricordati, che i tuoi lettori son uomini, e che il cuore umano si conforta di migliori affezioni. Cessa una volta di dipingere il delitto con troppo seducenti colori: la gioventù italiana legge avidamente i tuoi scritti, e le tue lettere le hanno fatto un danno gravissimo. Anche la Ricciarda non è affatto innocente: ammirando il tuo ingegno, noi sentiamo il dovere di far accorti i meno prudenti, che non è sempre cauto abbandonarsi a quegli impeti che tu sai ispirare. Pensa anche alla tua felicità, che oramai fosti travagliato abbastanza: gl'invidiosi ed i malignanti sono un popolo infinito: lasciali garrire a lor senno: non possono arrivare fino a te quelle voci: vieni a cantare fra noi le lodi della virtù e le bellezze della natura: se tu non sai essere felice in Italia, è necessario che la tua anima voli in traccia d'un mondo migliore.
